
Nel 1810, un anno prima di togliersi la vita, Heinrich von Kleist scrive un testo, un saggio breve dal titolo Sul teatro di marionette, che verrà pubblicato in quattro puntate sul “Berliner Abendblätter”. Il testo è un dialogo filosofico tra l’autore e un artista marionettista. Un dialogo particolare, poetico e filosofico insieme (un lyrical essay si direbbe oggi), in cui quello che emerge con forza è il pensiero espresso dal marionettista, tanto radicale quanto deciso e chiaro. L’assunto secondo il quale la perfezione e la grazia del movimento stanno dalla parte della marionetta più che dell’essere umano: «Ogni movimento, mi spiegò, ha un centro di gravità; basta dominare questo, nell’interno del fantoccio; le membra, che sono soltanto pendoli, seguono meccanicamente da sé, senza bisogno d’interventi»[1].
Ma questa semplicità, prosegue l’artista di strada, non vuol dire affatto che il movimento sia meccanico, o banale, tutt’altro. In un certo senso, la danza della marionetta esprime qualcosa di sublime, di superiore. Se un abile artigiano avesse potuto costruire una marionetta dal meccanismo perfetto, il marionettista avrebbe potuto con essa eseguire una danza che nessun ballerino sarebbe stato capace di eguagliare. Perché in quella marionetta ogni elemento, ogni gesto si sarebbe fondato su un preciso centro di gravità, in grado di raccoglierne e concentrarne l’essenza.
Ma quale sarebbe il vantaggio di questa marionetta? «Anzitutto un vantaggio negativo, mio egregio amico, che cioè questa non sarebbe mai affettata. Infatti, l’affezione si manifesta, come lei sa, quando l’anima (vis motrix) si trova in qualche punto diverso dal centro di gravità del movimento. Ora siccome il marionettista, mediante il filo di ferro o lo spago, non ha in suo potere nessun altro punto se non questo, tutte le altre membra sono ciò che devono essere, morte, semplici pendoli, e seguono soltanto la legge di gravità»[2]. Il vantaggio è negativo, afferma il marionettista, ma negativo in senso puramente di sottrazione: rispetto all’essere umano, ciò che manca alla marionetta è la conoscenza, la consapevolezza di sé e del mondo. Vale a dire, è impossibile per la marionetta sbagliare («Mi misi a ridere. Certo, pensai, lo spirito non può sbagliare dove non esiste»[3]).
Ed è questa la straordinaria conclusione del testo di Kleist. La grazia superiore della marionetta sta proprio nel suo non essere cosciente di sé, di essere priva di spirito. Questo le permette di essere immediatamente e totalmente avvolta nella bellezza e nella grazia dei movimenti, molto più che il più grande dei ballerini.
Ed ecco allora, gradualmente, rovesciarsi il percorso tipico dell’antropologia religiosa, quella che dall’inanimato e dall’animale giunge all’uomo come creatura divina, dotata di quella grazia che può portarlo alla salvezza. Kleist invece, attraverso la figura straordinaria del marionettista rovescia totalmente il discorso, consegnandoci una conclusione che apre a una serie di letture quanto mai contemporanee: «Ebbene, mio ottimo amico (…), adesso lei possiede tutto quanto è necessario per comprendermi. Noi vediamo come, a misura che nel mondo organico la riflessione si ottenebra e s’indebolisce, la grazia vi emerga più radiosa e dominante – Ma come l’intersezione di due linee da un lato di un punto, dopo aver attraversato l’infinito, si ritrova improvvisamente dall’altro lato, o come l’immagine dello specchio concavo, dopo essersi allontanata nell’infinito, riappare improvvisamente vicinissima a noi, così anche la grazia si ripresenta, quando la conoscenza è passata, per così dire, attraverso un infinito, di maniera che si manifesta, nella sua forma più pura, in quel corpo umano che non ha affatto coscienza o l’ha infinita, cioè nella marionetta o nel dio»[4].
Un dialogo di poche pagine, pubblicato a puntate in un giornale tedesco all’inizio dell’Ottocento. Eppure, rileggendo il breve testo di Kleist a distanza di più di due secoli, quelle parole, quelle immagini riecheggiano con una forza straordinaria.
L’automa, la marionetta, l’essere artificiale, meccanico, o meglio tecnologico. Il potenziamento dei corpi mediante dispositivi (come gli arti artificiali, gli impianti digitali, l’estensione tecnologica del corpo) si pongono nella visione di Kleist come l’equivalenza della perfezione, che ha due poli, la coscienza infinita (divina) o la totale mancanza di coscienza.
La marionetta è perfetta, essa può porsi come specchio, come linea opposta ma convergente del divino; l’umano no. Ripensato con uno sguardo contemporaneo, il dialogo kleistiano sembra riattraversare retrospettivamente le molteplici immagini e incarnazioni della marionetta nel corso del Novecento e nel nuovo millennio: incarnazioni che aprono percorsi diversi, come le linee di fuga convergenti del finale del testo di Kleist.
Ecco infatti muoversi, lungo la linea della perfezione del gesto, l’automa benjaminiano, con cui si aprono le Tesi sul concetto di storia: «Si dice che ci fosse un automa costruito in modo tale da rispondere, ad ogni mossa di un giocatore di scacchi, con una contromossa che gli assicurava la vittoria. Un fantoccio in veste da turco, con una pipa in bocca, sedeva di fronte alla scacchiera, poggiata su un’ampia tavola. Un sistema di specchi suscitava l’illusione che questa tavola fosse trasparente da tutte le parti. In realtà c’era accoccolato un nano gobbo, che era un asso nel gioco degli scacchi e che guidava per mezzo di fili la mano del burattino. Qualcosa di simile a questo apparecchio si può immaginare nella filosofia. Vincere deve sempre il fantoccio chiamato «materialismo storico». Esso può farcela senz’altro con chiunque se prende al suo servizio la teologia, che oggi, com’è noto, è piccola e brutta, e che non deve farsi scorgere da nessuno»[5].
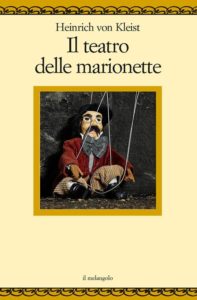 Il fantoccio di Benjamin, immaginato centotrenta anni dopo quello di Kleist si pone immediatamente come personaggio concettuale: l’automa deve avere al suo interno un’anima (vis motrix, direbbe Kleist), che gli permette di muoversi efficacemente, di unire il rigore del materialismo con la potenza trasfigurante della teologia. Ed ecco allora una prima incarnazione della marionetta che si pone come forma superiore dell’essere: l’incarnazione cioè della forma ibrida, della potenza del meccanismo unita alla forza vitale del pensiero, o dell’anima. Come afferma Michael Löwy, il pensiero che diventa puro metodo analitico è una forma vuota, incapace di vincere la partita. Agli occhi di Benjamin, il materialismo storico diviene per i marxisti a lui contemporanei una sorta di macchina automatica, «un metodo che intendo la storia come una specie di macchina che porta “automaticamente” al trionfo del socialismo»[6]. Ma questa incarnazione va in un’altra direzione rispetto alla potenza della marionetta di Kleist. L’automa di Benjamin è una delle prime rappresentazioni della potenza razionale della tecnica (che sia tecnologia materiale o tecnologia del metodo di analisi della realtà non cambia molto); una potenza che attraversa tutto il Novecento e che le forme espressive ed artistiche del secolo breve hanno efficacemente rappresentato.
Il fantoccio di Benjamin, immaginato centotrenta anni dopo quello di Kleist si pone immediatamente come personaggio concettuale: l’automa deve avere al suo interno un’anima (vis motrix, direbbe Kleist), che gli permette di muoversi efficacemente, di unire il rigore del materialismo con la potenza trasfigurante della teologia. Ed ecco allora una prima incarnazione della marionetta che si pone come forma superiore dell’essere: l’incarnazione cioè della forma ibrida, della potenza del meccanismo unita alla forza vitale del pensiero, o dell’anima. Come afferma Michael Löwy, il pensiero che diventa puro metodo analitico è una forma vuota, incapace di vincere la partita. Agli occhi di Benjamin, il materialismo storico diviene per i marxisti a lui contemporanei una sorta di macchina automatica, «un metodo che intendo la storia come una specie di macchina che porta “automaticamente” al trionfo del socialismo»[6]. Ma questa incarnazione va in un’altra direzione rispetto alla potenza della marionetta di Kleist. L’automa di Benjamin è una delle prime rappresentazioni della potenza razionale della tecnica (che sia tecnologia materiale o tecnologia del metodo di analisi della realtà non cambia molto); una potenza che attraversa tutto il Novecento e che le forme espressive ed artistiche del secolo breve hanno efficacemente rappresentato.
Benjamin è dunque un esempio di quella necessità che il Novecento ha sempre sentito di animare la macchina, di instillare nella marionetta l’élan vital dello spirito. Il XX secolo ha infatti pensato la vita come relazione tra organico e inorganico, come rapporto problematico e aperto, conflittuale persino tra automazione e volontà, tra meccanico e umano. L’automa è dunque ciò che spaventa se non è controllato dall’uomo, da uno spirito che impedisce la sua esistenza come radicalmente altra. Lo spirito e la macchina – the Ghost and the Machine – devono amalgamarsi in modo tale che nessuno dei due prevalga sull’altro. La macchina spaventa se separata dal controllo umano.
Il robot Maria di Metropolis (1927) di Fritz Lang è una delle prime rappresentazioni di questa paura. Un automa che ha le sembianze di una donna reale, che seduce e cattura lo sguardo, che aizza la popolazione alla rivolta, alla rivoluzione. Che deve essere distrutto, pena la distruzione totale della città di Metropolis. I robot immaginati dalla letteratura e dal cinema – da Karel Čapek che ne inventa il nome in R.U.R. (1920), ad Asimov che ne codifica la dipendenza dall’uomo nelle famose tre leggi della robotica in Io, robot (1950); da Fritz Lang che ne rivela il lato perturbante ai replicanti di Philip K. Dick resi celebri da Ridley Scott in Blade Runner (1981) – Questi robot/automi, forme novecentesche della marionetta, mostrano l’inquietudine di ciò che Kleist presenta come la forma sublime nel teatro di marionette: la perfezione che fa a meno dell’umano, che ne supera l’affettazione, l’autocoscienza, la volontà.
Le due linee che si intersecano nel testo di Kleist non fanno che allontanarsi allora? La marionetta contemporanea si pone come lo spauracchio di un mondo senza più l’umano? In realtà c’è un’altra linea che prende forma dalle riflessioni dello scrittore tedesco: ed è quello, opposto, della marionetta come forma radicale dell’umano. Il corpo inorganico, la marionetta, il burattino che si muove solo grazie al marionettista può avere vita propria? Non è un caso allora che Pinocchio ha uno scatto d’ira proprio quando il Grillo parlante gli ricorda che è un burattino di legno? «Povero Pinocchio! Mi fai proprio compassione!… – Perché ti faccio compassione? – Perché sei un burattino e, quel che è peggio, perché hai la testa di legno»[7].
Essere un burattino, avere la testa di legno: a questo Pinocchio si ribella, scagliando il martello sulla testa del grillo parlante. Eppure in questa figura di burattino senza fili, straordinaria e unica che è Pinocchio si agita in fondo un archetipo potente, come ricordano Manganelli e Agamben (quest’ultimo discostandosene un poco): il burattino come vittoria sulla condizione puramente naturale e sulla condizione puramente meccanica, poiché Pinocchio non aderisce a nessuna delle due e si muove lungo entrambe le dimensioni: «Faticosa Vittoria! Collodi mostra come per ottenerla si deve rinunciare a ogni fede nelle istituzioni umane, liberarsi interamente dalla illusione della giustizia e dell’utopia»[8]. Ecco l’altra direzione delle linee divergenti del teatro di marionette: quella che rende autonoma l’esistenza della marionetta, senza controllo da parte dell’uomo (Pinocchio si ribella sin dal primo momento di esistenza, guardando senza ritegno Geppetto che lo sta creando da un pezzo di legno).
Se il burattino o la marionetta non hanno più bisogno di essere guidati, ma appunto acquistano volontà e coscienza di sé essi diventano assolutamente umani, ne sono, dell’umano, la versione più autentica, libera dalle illusioni del libero arbitrio, della volontà e del controllo di sé. L’umano che si scopre burattino realizza la potenza delle forze che lo condizionano, che lo fanno essere ciò che è. Ed è Pasolini l’autore che probabilmente ha portato al massimo grado questo riconoscimento, in quel cortometraggio capolavoro che è Che cosa sono le nuvole? (1968). Mentre in un teatro dei burattini situato in una non ben precisata periferia romana si svolge una rappresentazione dell’Otello di Shakespeare, gli stessi burattini cominciano a parlare tra loro, a farsi domande sul loro ruolo, sulla loro libertà, sulla verità. Otello (Ninetto Davoli) chiede allora al burattinaio (Francesco Leonetti) e poi a Jago (Totò), il senso della sua esistenza:
«Otello– A sor Mae’! Ma perché io credo a Jago? Perché so’ così stupido?
Burattinaio – Forse …è perché sei tu, che vuoi ammazzare!
Otello – Come? Me piace ammazzare? E perché?
Burattinaio – Forse …. perché a Desdemona piace essere ammazzata…
Otello – Ah! E’ così?
Burattinaio –Forse, è così.
Otello – Ma allora qual è la verità? Quello che penso io de me, quello che pensa la gente o quello che pensa quello là dentro …
[..]
Jago – Senti qualcosa dentro di te? Concentrati bene! Senti qualcosa? Eh?
Otello – Sì … sì ….sento qualcosa … che c’è …
Jago – Beh … Quella è la verità …Ma ssssst, non bisogna nominarla, perché appena la nomini non c’è più …»[9]
È allora qui, in questo dialogo tra Otello, il burattinaio e Jago che un’altra linea del teatro di marionette trova una delle sue massime rappresentazioni. Dalla marionetta che esiste solo in quanto “animata” al burattino che diventa la vera rappresentazione dell’umano, il percorso è ricco, ricchissimo di esempi, di guardi che hanno costruito percorsi, immaginari, visioni.
Ma l’enigma di Kleist continua, perché in fondo, l’inquietante equivalenza tra un dio e una marionetta porta la ricerca della perfezione come ciò che è al di là dell’umano, al di là di ogni imperfezione, esitazione, pensiero, dubbio che agita la dimensione umana. Kleist allora va al di là del Novecento. La macchina/marionetta non ha a che fare con l’umano, ma con la perfezione assoluta, con dio. La sua dimensione inquietante e affascinante si lega allora all’immaginario del nuovo millennio, al nuovo mito della ricerca dell’intelligenza artificiale, dell’esistenza della macchina non in quanto sostituto dell’umano, ma come nuova dimensione del divino.
È l’ultima, radicale e assolutamente contemporanea linea che occorre seguire, e che collega direttamente il testo dello scrittore tedesco al nostro secolo, il secolo del sogno/incubo della mente artificiale, dell’universo di Matrix delle sorelle Wachowsky (1999-2022), del mondo delle macchine di Terminator (1984) di James Cameron, fino ai primi pallidi, balbettanti (e perturbanti) tentativi di esistenza di ChatGPT o MidJourney. Tornare a Kleist significa allora forse fare una volta ancora quel movimento già annunciato nel finale del testo; di sfuggita e distrattamente, ma con decisione. Creare un nuovo pensiero, un nuovo sapere, in grado di non essere solo testimoni di una mutazione radicale, dell’avvento di una nuova metafisica della macchina, proprio durante un’epoca che si percepisce come l’ultima: «“Sicché” dissi un po’ distratto, “dovremmo mangiare di nuovo il frutto dell’albero della conoscenza per ritornare allo stato di innocenza?” “Eh sì” rispose. “Questo è l’ultimo capitolo della storia del mondo”[10].
Daniele Dottorini e Sandra Viviana Palermo
[1]E. von Kleist, Sul teatro di marionette. Aneddoti, saggi, Guanda, Parma 1986, p. 32.
[2]Ivi, p. 33.
[3]Ivi, p. 34.
[4]Ivi, p. 37.
[5]W. Benjamin, Tesi sul concetto di Storia, Mimesis, Milano 2013, p. 6.
[6]M. Löwy, Segnalatore d’incendio. Una lettura delle tesi Sul concetto di Storia, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, p. 37.
[7]C. Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Rizzoli, Milano 1949, p. 12.
[8]G. Agamben, Pinocchio. Le avventure di un burattino doppiamente commentate e tre volte illustrate, Einaudi, Torino 2021, p. 12.
[9]Dialogo dal film.
[10]H. von Kleist, Sul teatro di marionette, cit., p. 37.
