Ex favula oritur ius
Non esistono fatti, solo… prove!
Molti elementi concorrono al funzionamento del motore epistemico processuale. Qui non si intende entrare con i piedi nel piatto della questione se il processo debba paranoicamente perseguire la verità ‘vera’ o debba accontentarsi di una più modesta veritàprocessuale: non si useranno metafore come quella della armonica quadratura del cerchio o della asintoticità della tangente. La questione rimane sullo sfondo, mentre i drammi che si svolgeranno sul proscenio consentiranno di distinguerne qualche tratto significativo.
I casi di violenza (sessuale o ‘domestica’) sulle donne o sui minori sono come dei vulcani per l’attività sotterranea del magma della giustizia: vi si concentrano una serie di problemi probatori e di giudizio che sollevano il velo di Maya sulla chimica della ricerca della verità nel laboratorio processuale.
La vicenda biblica di Susanna fa letteralmente esplodere il processo sotto l’effetto di una granata profetica caduta dall’alto: solo l’intervento esterno del giovinetto Daniele, ispirato direttamente da Dio,consente il raggiungimento della verità. La vicenda di Artemisia mostra un opposto metodo: accumulare evidenze su evidenze. Il ruolo della magnifica pittrice è fondamentale, ma non ancora decisivo: conta la quantità dei testimoni. La vicenda di Adela Quested in Passaggio in India di Forster, pur chiudendosi con la salvezza dell’innocente,vede come unica protagonista la presunta vittima, che si scopre infine essere stata vittima solo della sua stessa suggestione.
Attraverso le maglie narrative e simboliche di questi tre ‘racconti’emergono considerazioni sul ruolo dell’atteggiamento epistemico attraverso il quale ci si rivolge a un oggetto come la testimonianza,aspettandosi che contenga una verità.
Susanna e i vecchioni: la verità… al momento giusto

La scena di Susanna e i Vecchioni trova luogo nel tredicesimo capitolo del Libro di Daniele. Il motivo fondamentale è quello della protezione divina del perseguitato (oggi diremmo: dai poteri forti o dal sistema giustizia). Dal punto di vista narratologico,Daniele è un eroe che concentra in sé i tratti della saggezza e della giustizia. Susanna d’altro canto è colei che preferisce esporsi a un processo dall’esito quasi certamente infausto invece che scendere a patti con i suoi aguzzini (oggi diremmo: invece di patteggiare!).
Si deve notare come il racconto è ricco di particolari relativi alla “scena del crimine”: tutto è dettagliato per far capire come ogni fatto può essere usato contro Susanna: le porte chiuse, le ancelle mandate fuori dal giardino, l’assenza di terzi testimoni. Gli ingannatori hanno dunque predisposto un quadro probatorio pronto per passare “nel fascicolo del dibattimento”. Ma soprattutto, per quanto inverosimile possa apparire il loro racconto, nessuno oserà mettere in dubbio la loro credibilità. Qui s’inserisce il magnifico Cantico di Susanna, fulgido esempio di un topos letterario che porta sino alla Lucia prigioniera dell’Innominato. Siamo per così dire sulle soglie della Camera di Consiglio, le bocce processuali sono ferme, non vi è nulla, nelle fatidiche “maglie della legge” che possa ribaltare la situazione. Solo una rottura del sistema della giustizia (umana) può rimettere il vagone del controllo sociale sui binari della corretta destinazione (i.e. della verità): “il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto, chiamato Daniele…”.
Ed ecco il meccanismo fuori squadra che scuote una procedura inane alla scoperta della verità: invece di ascoltare passivamente le loro deposizioni e recepirle come oro colato, il giovinetto suggerisce: “Separateli bene l’uno dall’altro e io li giudicherò”. Si tratta di un’applicazione della teoria dei giochi (il celebre dilemma del prigioniero) in anticipo di oltre venti secoli su Nash!
La storia a questo punto è nota: Daniele domanda, prima all’uno e poi all’altro, sotto quale albero sarebbe avvenuto il misfatto. Il primo risponde “sotto un lentisco”, il secondo “sotto un leccio”. “Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di aver deposto il falso”.
Ciò che ci si può chiedere è: la blind cross-examination sarebbe oggi possibile? E se possibile, sarebbe davvero auspicabile? Si è detto che Salomone ha potuto assurgere a prototipo del giudice saggio con il suo ‘trucchetto’ solo perché non c’era una legge scritta che egli dovesse applicare invece di poter gestire a suo piacere il dibattimento (oppure perché non c’erano a quei tempi le analisi del DNA!). Così è per Daniele, che viene investito di ‘poteri speciali’ da parte del popolo-giudice dopo che il sospetto di stare decidendo male si insinua nella forma del ragionevole dubbio.
Il processo (ad) Artemisia Gentileschi: uno stupro anacronistico

Facciamo un salto di più di quindici secoli. Il caso Tassi – Gentileschi fece scalpore nella Roma papalina. Il colpevole aveva rifiutato l’attesa riparazione (il matrimonio in salvezza dell’onore), come nel processo degli anni ’60 per la violenza subito da Franca Viola era stato il rifiuto della coraggiosa donna siciliana a propiziare un percorso di coscientizzazione che avrebbe condotto alla riforma del diritto di famiglia. Dai verbali del processo (che sembrano davvero il brogliaccio di un copione per una messinscena) apprendiamo che al tempo del fatto Artemisia aveva quindici anni e Agostino Tassi circa trentadue.
Il processo sollevò la lapide del sepolcro male imbiancato costituito dalla discutibilesituazione personale del Tassi. Dopo l’affaire Gentileschi, Tassi continuò ad accumulare processi e violenze: la sua fedina (se ve ne fosse stata una) avrebbe contemplato tra l’altro incesto, sodomia, furti, debiti e persino omicidio. D’altra parte Tuzia (la dama di compagnia) depose evasivamente e con qualche ambiguità, dal momento che – per la sua posizione di chaperon – una responsabilità diretta (e non per semplice concorso) sarebbe ricaduta su di lei per non aver vigilato sulla virtù di Artemisia.
Artemisia fu sottoposta dapprima a quella che oggi chiameremmo una prova tecnica: una sorta di periziaavente a oggetto l’avvenuta deflorazione. Due levatrici eseguirono una visita ginecologica confermando. Ma il vero atto di autoaccusa involontario di Agostino Tassi fu negare incrollabilmente qualunque rapporto sessuale con la vittima.
Elizabeth Cohen invita a rileggere il racconto dello stupro come storia, disincrostandolo da tutti gli anacronismi del caso. Il tono drammatico e il linguaggio ricco e forbito dei verbali nasconde la natura di doppio artefatto della testimonianza (da parte dei protagonisti; da parte degli organi di giustizia). Il processo è multivocale, è un ordito nel quale l’apparente conformità del contenitore (le formalità giuridiche sono uguali per tutti), lascia intatte le differenze e le peculiarità degli attori. Ciò che i testimoni riferiscono non è una radiografia obiettiva del mondo: piuttosto è uno schizzo, secondo le loro capacità retoriche, di ciò che il loro interesse nella causa li conduceva a portare davanti al giudice. Mettersi nei panni dei giudicanti significa fronteggiare una cacofonica massa di affermazioni sincere e d’ingenue dissimulazioni, di pretese verosimiglianze e di bugie sfacciate: il processo era infatti un processo di parti e tutti i testi assumevano piuttosto la posizione d’interventori ad adiuvandum, che non di informatori terzi su circostanze oggettive.
Insomma, assistiamo a un processo che è proprio di ogni teste in ogni giudizio e particolarmente di quello specifico teste privilegiato/penalizzato che è la vittima di violenza sessuale: nell’esprimersi, alla ricerca di una ricostruzione non solo dell’accaduto, Artemisia incontra e si scontra con le scansioni procedurali della legge, con la convenzionalità della retorica forense, con la micropolitica della gestione della giustizia.
Passaggio in India: una teste fantasma e la ritrattazione di Chandrapore
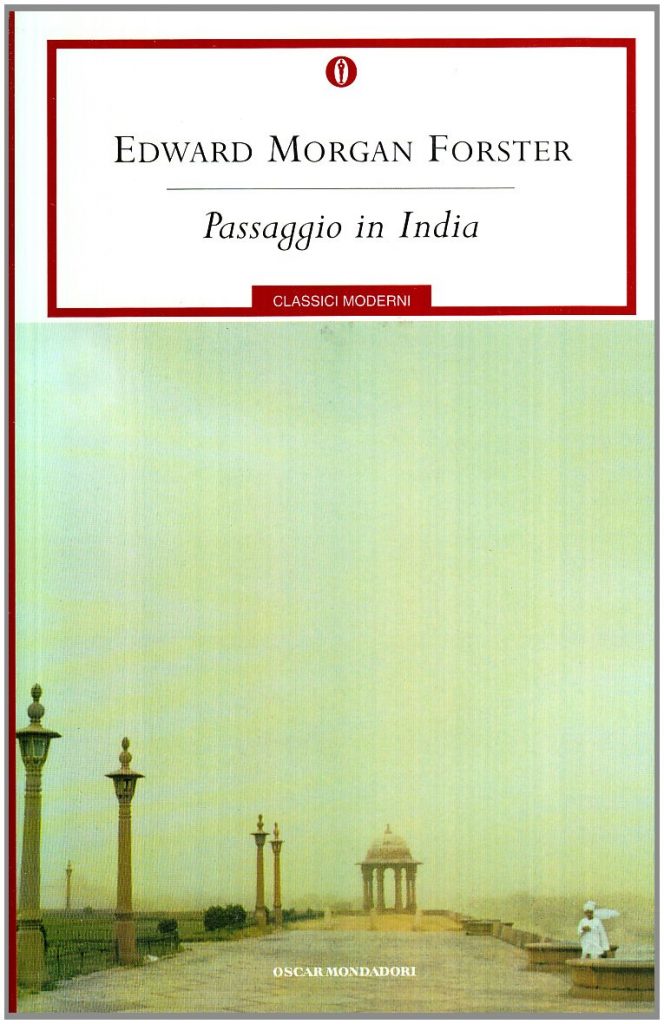
Una frase di Forster recita: “It is function of the novelist to reveal the riddle of life at its source: to tell us more than could be known. Though the intellect is our best friend, there are regions whinther it cannot guide us”. Si potrebbe benissimo sostituire il romanziere con il giudice o con l’avvocato impegnati in un giudizio riguardante un episodio di violenza sessuale e l’epigramma non ne risentirebbe.
Rivolgendosi perciò direttamente al momento in cui si giunge davanti ai giudici, il lettore è in un certo senso nella posizione (virgin minded) della Corte, poiché non gli è dato sapere cosa davvero sia successo nelle Grotte di Marabar.
Il tribunale di Chandrapore è uno dei luoghi essenziali del libro. Compaiono sulla scena gli attori principali, e fra essi svetta l’accusa. L’epistemologia spicciola che sottende la dichiarazione iniziale del Pubblico Ministero tradisce, in realtà, un’assoluta assenza di strategia dovuta proprio all’ingenuità di ritenere che la verità,per essere tale, debba essere anche auto-persuasiva, e dunque non meritevole di altra fatica per essere dimostrata.
Sia l’accusa sia la difesa hanno sempre saputo che una prova regina, la testimonianza di Mrs. Moore, poteva da sola far pendere il piatto della bilancia della giustizia (e per questo Mrs. Moore è stata fatta allontanare con uno stratagemma da parte della Procura). Il dialogo a questo punto si fa più serrato. La scena madre può finalmente avere luogo.
“Temo di aver commesso un errore”:
“Che specie di errore?”.
“In realtà il dottor Aziz non mi ha mai seguita nella grotta”. (…)
“Ritirate l’accusa? Rispondetemi” gridò il presidente della giustizia.
Qualunque cosa entri nel giudizio, quale sia la verità lo si può sapere solo all’esito del (e grazie al) giudizio stesso.
C’è una cosa che questo immenso romanzo ci insegna ancora oggi: se mai fosse corretto dire che la verità è il contrario del mistero (memorabili le parole dell’iniziale dialogo notturno nella moschea fra Aziz e Mrs Moore), bisognerebbe ammettere che non gli è però del tutto estranea. L’ultimo elemento della triade ideale che scandisce il romanzo (Moschea, Grotte, Tempio) descrive,attraverso l’immagine della festività indù,questa disordinata commistione e dovrebbe perciò essere un monito per tutti coloro i quali, fra i giuristi, si autonominano difensores fidei della presunta dimensione veritativa del processo: occorrerebbe semmai scordare una nostra certa “mania coloniale” per i dettagli e acquisire l’umile capacità cogliere un ordine più vasto.
Ora, l’accusa, così come l’evento stesso (il fatto di reato), sono entrambi completamente elisi ed eclissati, ovvero indicati con una circumlocuzione o più precisamente una perifrasi. Non si parla mai di stupro, di stupratore, di violenza carnale ecc.: dove dovrebbe esserci il nome della cosa c’è un vuoto ovvero la figura retorica. Proprio le motivazioni delle sentenze sono un trionfo diperifrasi, parafrasi, sineddoche e metonimia: “Parole, parole, parole,… come se ci fosse una qualunque cosa che può essere detta a parole…”. L’allusione a questa sorta di afonia non è tanto una questione di soprannaturale (una questione metafisica), ma proprio di metalinguistica: si tratta di riconoscere e rispettare quella parte della mente che, a volte, parla attraverso un qualche riverbero spirituale, in una sorta di “incantamento dell’ignoto” (con la non piccola notazione che nell’espressione ravishing the unknown il verbo ravish può significare anche… ‘stuprare’!).
Si potrebbe parafrasare una battuta di Passaggio in India (opportunamente sostituendo al sub-continente fisico “India”, il continente teoretico della “verità”): “Come può la mente abbracciare tutto questo paese? Generazioni di invasori ci hanno provato, ma sono rimasti in esilio…”. Per il giurista, rimanendo dentro la metafora, queste riflessioni sono un monito a ricordare che la motivazione delle sentenze è solo un vago tentativo di rendere intellegibile, la Verità del Lebenswelt che invece lascia inesorabilmente in esilio tutti coloro che tentino di colonizzarla.
Evidenza della verità (in tribunale)
Ecco dunque il problema comune alle tre storie: la vittima anche testimone, sola testimone, non solo testimone.
La verità è paradossale, e il compilatore del Libro di Daniele sembrava averlo compreso, così come lo sapeva benissimo in cuor suo Artemisia e come aveva capito appena in tempo Adela Quested: la vittima è più interessata alla sopravvivenza che non alla ricerca della verità nel processo. Dando anche solo uno sguardo a volo d’uccello alle motivazioni delle sentenze in materia di abusi si troverebbero interessantissimi appigli per capire non solo che a volte la realtà supera l’immaginazione, ma anche quanto di ‘narrativo’ (e retorico) vi sia nella pratica forense del caso concreto.
Ci possiamo domandare: che tipo di verità riteniamo che sia stato ‘scoperto’ o ‘rivelato’ nei nostri tre casi letterari? La prima è una verità extrasistemica, non scoperta logicamente, ma pragmaticamente, attraverso un vero e proprio trucco. La seconda è una verità per accumulo, ottenuta al tornio, cesellata, multistrato: una verità sfumata, nella quale una miriade di pixel (decine e decine di testimonianze) finisce per comporre la figura complessiva del quadro ultimato. La terza, infine, è davvero una verità elargita dal solo testimone diretto: una verità negativa, originaria, nel senso di una rinuncia assoluta a qualunque apparenza (a qualunque evidence).
Nel caso di Susanna noi “sappiamo come stanno le cose”, nel senso che è lo stesso narratore a dircelo: Susanna è innocente. Sulla base di questa premessa possiamo poi giudicare se l’esito del processo corrisponde alla verità o no. Nel caso di Adela Quested la nostra postura è quasi analoga, sebbene non esattamente la medesima, poiché già si allenta l’univocità e la certezza di quel rapporto di rispecchiamento fra il presunto “fatto” e la verità finale del giudizio. Lo specchio della natura, insomma, presenta già qualche incrinatura di ambiguità, di ricchezza semantica, d’indecidibilità linguistica. Nel caso di Artemisia, infine, e non per nulla si tratta dell’unico caso “vero” (nel senso di “storico”), noi ci troviamo invece, sia pure ex post, nella stessa posizione epistemica ‘vergine’ del giudice, e dunque siamo presi da una vertigine ben maggiore: ciò che possiamo esprimere sono solo (si fa per dire) giudizi, supposizioni, convinzioni. Leggere le carte del processo ci “convince” che giustizia sia stata fatta oppure no, secondo che “crediamo” ad Artemisia o a Agostino, a Tuzia e al Quorli o allo Stiattesi.
Ifatti (queste cose molto cosali che dovrebbero contenere in sé il dato stesso di essere dure, reali, esistenti, inattaccabili) non sono più univoci delle opinioni. Almeno non tutti. Tanto per dirne una, i fatti di relazione, come il rapporto carnale in determinate condizioni, non solo scontano un certo prospettivismo, quanto piuttosto sono costituiti – interamente – dalle prospettive stesse degli agenti coinvolti: osservando due persone che si congiungono con modalità particolarmente agonistiche in un’auto parcheggiata in un luogo appartato, il carabiniere di ronda può solo credere (non sapere) che si stia consumando un reato (come può solo credere– non sapere – che nulla di penalmente rilevante sta avendo luogo).
La verità del processo si forma nel processo. Le prove, che sono gli scambiatori dei processi di comunicazione fra due mondi (reale e processuale), sono fatte di linguaggio, cioè della stessa materia di cui sono fatti i racconti. Pensare che la verità abbia altre forme di accesso all’interno del processo è altrettanto stolto che credere che la legge di non penetrazione dei corpi non esista. Per quanto la costatazione possa essere ‘amara’, girare e voltare furiosamente il cucchiaino delle nostre pretese (talvolta un po’ paranoiche) non farà sciogliere nel caffè giudiziario un solo grammo in più dello zucchero della verità.
Ne consegue una sorta di “autarchia” della verità. Chi pensa il contrario e si perita di sostenerlo non è in effetti solo, né ha poche frecce all’arco. Esiste, infatti, un pensiero occidentale di primaria grandezza giusto il quale la ragione, il linguaggio e il loro rapporto con la verità sono essenzialmente antiretorici. In epoca moderna ha avuto grande credito la tendenza ad identificare la verità con l’evidenza (parola molto… processuale). Una verità che coincide con l’evidenza non ha bisogno di nient’altro che di una cartesiana “mente attenta” e capace di coglierla: essa è per così dire auto-persuasiva. Il fatto è che evidenti sono le proposizioni, ma mai le argomentazioni. Si tratta di riconoscere che il linguaggio non è (mai) unicamente informativo (un semplice veicolo sul quale caricare dati con biglietto di sola andata), ma sempre intrinsecamente persuasivo (in quanto ha almeno uno scopo retorico imprescindibile: essere creduto).
La letteratura crea personaggi, mentre il diritto punisce le persone in carne ed ossa. E i giudici (e gli avvocati) sono appunto persone, con tutti i loro limiti non solo psicologici e idiosincratici, ma anche con i limiti che impone loro la legge ed il sistema.
Emanuele Filograna è avvocato. Attualmente lavora presso l’Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia. Laureato presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha conseguito il Master DASA in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione presso l’Università di Roma Tre e un Dottorato di Ricerca in Evoluzione dei Sistemi Giuridici e Nuovi Diritti presso l’Università del Salento. Ha pubblicato note a sentenza ed ha svolto attività di pubblicista. Recentemente ha conseguito presso l’Università di Perugia la Laurea Magistrale in Filosofia.
