Vol. 12, n. 1 (2020)
Ho riletto in questi giorni, forse per la terza o quarta volta, La Peste di Camus. Si dirà, con una certa dose di banalità, che non ci può essere lettura più in sintonia con il momento storico che siamo chiamati a vivere. Ma ho anche approfittato, grazie al tempo a disposizione e questo è l’unico aspetto positivo di questa clausura, per allargare lo sguardo non solo a Lo Straniero – l’altro romanzo più conosciuto dello scrittore franco-algerino, oggetto anch’esso di un paio di letture passate – ma all’insieme degli scritti e dell’attività pubblica di un intellettuale che ha profondamente segnato di sé la nostra contemporaneità molto più di quanto abitualmente si pensi. In verità, riflettendoci meglio, ciò che mi ha spinto a questa avventura intellettuale risiede a livello molto più profondo della contingenza restrittiva. Il riemergere di due ricordi – uno lontano nel tempo e l’altro assai più recente – di occasioni in cui mi sono trovato a contatto fisico con due luoghi simbolo del percorso di Camus: la baia di Tipasa e il cimitero di Lourmarin. La seconda ragione sta nelle riflessioni che ha indotto, credo non soltanto a me, la visita effettuata dal Papa nei primissimi giorni del lockdown a due luoghi simbolo della religiosità popolare di Roma.
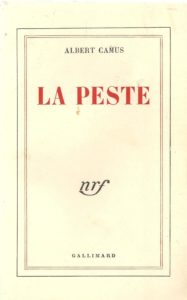
Dai ricordi vorrei partire per incrociare spezzoni dell’opera di Camus. Tra il 2006 e il 2007 ebbi modo di viaggiare spesso in Algeria a causa dell’incarico governativo che allora rivestivo come sottosegretario al commercio internazionale. In una di queste occasioni il governo algerino organizzò una visita al sito archeologico di Tipasa, località che dista 70/80 chilometri da Algeri lungo la route nationale che percorremmo insieme con l’ambasciatore italiano Verderami. Arrivati al polveroso piazzale d’ingresso al sito venimmo accolti dalla direttrice, una minuta signora quasi fragile che nascondeva una solidissima preparazione di carattere artistico e storico. Oltre al francese e all’arabo parlava con proprietà l’italiano avendo soggiornato a lungo per ragioni di studio a Palermo. Le famose spiagge sabbiose di Tipasa si affacciano su una baia di incantevole bellezza in cui si scontrano i colori del blu, del verde e dell’ocra. Se al primo approccio si ha l’impressione di non riuscire a sostenere l’intensità e la fisicità dei contrasti visivi, con il passare dei minuti quelle corposità si fondono magicamente in un ordine superiore che si spalma come un lenitivo sull’animo del visitatore. Ben presto, nel girare tra collinette e pietre, ascoltando le puntuali descrizioni della direttrice, una strana serenità finì per impadronirsi di me. Neanche la presenza vigile di alcune guardie a ogni sommità del terreno a ulteriore garanzia di sicurezza in un parco che pure era stato chiuso temporaneamente alla visita del pubblico, riusciva a compromettere quella gradevole sensazione. Una sensazione destinata a salire di un’ottava quando la direttrice mi indicò in lontananza proprio nel centro della baia una stele rettangolare di cui si intuiva l’essenziale sobrietà. Anche a distanza il contrasto tra il colore del piccolo monumento – un giallo ocra che si inasprisce di terra bruciata – e il verde sfacciato dei bassi cespugli intorno mi è arrivato dritto in faccia. È la stele dedicata a Albert Camus che lì spesso amava recarsi per ritrovare la centralità dell’uomo nella piena sintonia, quasi una consustanzialità, con la natura. Oggi, in questa sorta di sospensione del tempo operativo dovuta al coronavirus, terminata la lettura de La Peste, ho preso in mano lo snello volumetto in lingua originale che avevo infilato nella mia libreria di ritorno da chissà quale viaggio a Parigi. Un’edizione economica, semplicissima di Noces che si apre proprio con il racconto “Noces à Tipasa”. Prima di inoltrarmi nell’analisi di questo lavoro giovanile di Camus vorrei, però, raccontare la seconda occasione del mio “incontro” con il grande scrittore. L’ incrocio con i luoghi cari a Camus si è ripetuto poco tempo fa, per la precisione l’ultimo giorno dell’anno 2019. Qualche giorno prima il Robinson di Repubblica ha pubblicato un’intervista alla figlia dello scrittore nel sessantennale della morte avvenuta il 4 gennaio del 1960. All’intervista, abbastanza modesta, seguono invece due bei pezzi di Kamel Daoud e di Dario Olivero di ben altro spessore. Mi trovo a leggere l’inserto durante una brevissima vacanza a Aigues Mortes. La decisione, insieme alla mia compagna, di fare una puntata a Lourmarin, località del primo entroterra della Provenza è immediata. Lì Camus acquistò con i soldi del Nobel che gli era stato assegnato nel 1957 una bella casa dove oggi sono custodite le sue carte e, nel piccolo cimitero vicino al castello che domina il villaggio, è sepolto. Nel cimitero nessuna indicazione aiuta a individuare il luogo di sepoltura. Insieme a noi entrano un gruppetto di turisti francesi. Decidiamo di organizzarci per operare un piccolo rastrellamento alla ricerca della tomba. Di semplicità assoluta, a terra, a fianco della moglie che solo con la morte potrà godere dell’esclusività del rapporto con il marito, uniti, oltre che dalla vicinanza, da un arbusto, un oleandro forse, che si radica e prende vita da tutte e due le tombe. Intorno il silenzio tipico di questi luoghi sembra anche più profondo, quasi pastoso. Sullo sfondo il profilo delle alte colline della Provenza, quella riunificazione tra uomo e natura in cui lo scrittore si immergeva sulle sponde del Mediterraneo si avverte anche qui in forme tutt’altro diverse.
 Veniamo ora all’altra ragione che mi ha spinto atornare ancora allo scrittore franco-algerino. Non appaia eccentrico l’accostamento che mi accingo a proporre, in effetti un filo sotterraneo lega la problematica affrontata da due personalità tanto diverse e tanto lontane nel tempo come Camus e l’attuale Pontefice. Entrambi di fronte al medesimo dilemma: come si pone l’uomo davanti all’epidemia e a quali strumenti, integrandoli o contrapponendoli, la sua coscienza ritiene di attingere? Alla scienza o alla fede? Papa Francesco ha ritenuto opportuno uscire dal Vaticano per fare visita a Santa Maria Maggiore e “successivamente, facendo un tratto di Via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso per pregare per la fine della pandemia” (dal comunicato della Sala stampa Vaticana). In questa chiesa si trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città per invocare la fine della “Grande Peste” a Roma. L’iniziativa del Papa si presta a una serie di considerazioni, alcune delle quali in contrasto tra di loro, per l’intrinseca ambivalenza della mossa del pontefice. Un’interprestazione potrebbe porre l’accento sulla volontà esplicita di Francesco di manifestare la propria solidarietà visibile, direi fisica, sia a coloro che combattono in prima linea la malattia sia a coloro che restano chiusi in casa per impedire il diffondersi del contagio. Anche il richiamo a non comportarsi da Don Abbondio, il richiamo a avere coraggio, rappresenterebbe in questa visione uno stimolo al mondo cattolico a essere in campo con tutti i suoi mezzi nel contrasto senza esitazioni all’epidemia. Ma c’è qualcosa di un po’ più sotterraneo nel messaggio papale che può destare qualche perplessità. Innanzitutto stride con il senso comune di questi giorni l’immagine, che il Corriere della Sera riporta in prima pagina, del Papa che percorre a piedi una via del Corso deserta seguito a debita distanza da alcuni uomini della sicurezza. Questo nei giorni in cui è più vibrante l’appello di tutte le autorità a restare in casa. Certo il Pontefice non può essere considerato un cittadino comune e la sua uscita dalle mura vaticane riveste senza dubbio un carattere di eccezionalità. E qui viene, a incrementare le perplessità sulla scelta vaticana, la ragione che sottende l’eccezionalità: il “pellegrinaggio”, per usare il termine della Sala stampa Vaticana, alla chiesa di San Marcello in richiamo di una processione cinquecentesca per implorare la fine della pestilenza. Quasi che, nel pieno del dispiegamento delle azioni razionali di contenimento della diffusione del virus e delle raccomandazioni di comportamento basate su rigorose prescrizioni di carattere scientifico, il capo del cattolicesimo volesse ricordare la primazia della fede e del volere divino nella battaglia contro il contagio. Il gesto del Pontefice lascia a livello emotivo come un retrogusto di qualcosa di antimoderno, il riflesso di un tradizionalismo non coerente con la sua azione generale. Non credo però si possa dare spazio all’idea che si voglia così rievocare implicitamente un non risolto rapporto tra fede e scienza, riportando indietro le lancette dell’orologio. Appare piuttosto il tentativo di non perdere comunque il legame con alcuni aspetti di una religiosità popolare che in momenti critici come l’attuale tende a riproporre il suo ruolo. E qui ci sovviene Camus. Padre Paneloux, uno dei personaggi de La Peste, attraverso un lungo e travagliato percorso interiore, modificherà l’integralista approccio iniziale nei confronti della peste, proprio in forza di quella carità cristiana, anch’essa integrale, che lo porta a un contatto diretto e senza mediazioni con le sofferenze devastanti provocate dal morbo. Da un primo approccio di totale subordinazione degli sforzi (la scienza) degli uomini al volere divino (la fede) approderà a ben altra conclusione mettendo sé stesso al servizio dell’azione umana fino al sacrificio della vita. Leggiamo due brani significativi a sostegno di questa affermazione. “Il Padre, qui, riprese con maggiore ampiezza l’immagine patetica del flagello; evocò l’immensa trave di legno che roteava al di sopra della città, colpiva a caso sollevandosi sanguinante, e infine sparpagliava il sangue e il dolore umano < per le sementi che prepareranno le messi della verità>“ (pag. 75 dell’edizione Tascabili Bompiani). E più avanti al volgere dell’epidemia, nella seconda predica padre Paneloux afferma che “non bisognava tentare di spiegarsi lo spettacolo della peste, ma cercare di imparare quello che si poteva impararne”. Commenta il dottor Rieux che assiste all’orazione: “Gli sarebbe stato facile dire che l’eternità di delizie che aspettavano il bambino (morto per peste tra indicibili sofferenze ndr) potevano compensarlo della sofferenza, ma, in verità, lui non ne sapeva niente. Chi poteva affermare, infatti, che l’eternità di una gioia possa compensare un attimo del dolore umano? Non sarebbe sicuramente un cristiano, il cui Maestro ha conosciuto il dolore nelle membra e nell’anima” (pagg 172- 173).
Veniamo ora all’altra ragione che mi ha spinto atornare ancora allo scrittore franco-algerino. Non appaia eccentrico l’accostamento che mi accingo a proporre, in effetti un filo sotterraneo lega la problematica affrontata da due personalità tanto diverse e tanto lontane nel tempo come Camus e l’attuale Pontefice. Entrambi di fronte al medesimo dilemma: come si pone l’uomo davanti all’epidemia e a quali strumenti, integrandoli o contrapponendoli, la sua coscienza ritiene di attingere? Alla scienza o alla fede? Papa Francesco ha ritenuto opportuno uscire dal Vaticano per fare visita a Santa Maria Maggiore e “successivamente, facendo un tratto di Via del Corso a piedi, come in pellegrinaggio, il Santo Padre ha raggiunto la chiesa di San Marcello al Corso per pregare per la fine della pandemia” (dal comunicato della Sala stampa Vaticana). In questa chiesa si trova il Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città per invocare la fine della “Grande Peste” a Roma. L’iniziativa del Papa si presta a una serie di considerazioni, alcune delle quali in contrasto tra di loro, per l’intrinseca ambivalenza della mossa del pontefice. Un’interprestazione potrebbe porre l’accento sulla volontà esplicita di Francesco di manifestare la propria solidarietà visibile, direi fisica, sia a coloro che combattono in prima linea la malattia sia a coloro che restano chiusi in casa per impedire il diffondersi del contagio. Anche il richiamo a non comportarsi da Don Abbondio, il richiamo a avere coraggio, rappresenterebbe in questa visione uno stimolo al mondo cattolico a essere in campo con tutti i suoi mezzi nel contrasto senza esitazioni all’epidemia. Ma c’è qualcosa di un po’ più sotterraneo nel messaggio papale che può destare qualche perplessità. Innanzitutto stride con il senso comune di questi giorni l’immagine, che il Corriere della Sera riporta in prima pagina, del Papa che percorre a piedi una via del Corso deserta seguito a debita distanza da alcuni uomini della sicurezza. Questo nei giorni in cui è più vibrante l’appello di tutte le autorità a restare in casa. Certo il Pontefice non può essere considerato un cittadino comune e la sua uscita dalle mura vaticane riveste senza dubbio un carattere di eccezionalità. E qui viene, a incrementare le perplessità sulla scelta vaticana, la ragione che sottende l’eccezionalità: il “pellegrinaggio”, per usare il termine della Sala stampa Vaticana, alla chiesa di San Marcello in richiamo di una processione cinquecentesca per implorare la fine della pestilenza. Quasi che, nel pieno del dispiegamento delle azioni razionali di contenimento della diffusione del virus e delle raccomandazioni di comportamento basate su rigorose prescrizioni di carattere scientifico, il capo del cattolicesimo volesse ricordare la primazia della fede e del volere divino nella battaglia contro il contagio. Il gesto del Pontefice lascia a livello emotivo come un retrogusto di qualcosa di antimoderno, il riflesso di un tradizionalismo non coerente con la sua azione generale. Non credo però si possa dare spazio all’idea che si voglia così rievocare implicitamente un non risolto rapporto tra fede e scienza, riportando indietro le lancette dell’orologio. Appare piuttosto il tentativo di non perdere comunque il legame con alcuni aspetti di una religiosità popolare che in momenti critici come l’attuale tende a riproporre il suo ruolo. E qui ci sovviene Camus. Padre Paneloux, uno dei personaggi de La Peste, attraverso un lungo e travagliato percorso interiore, modificherà l’integralista approccio iniziale nei confronti della peste, proprio in forza di quella carità cristiana, anch’essa integrale, che lo porta a un contatto diretto e senza mediazioni con le sofferenze devastanti provocate dal morbo. Da un primo approccio di totale subordinazione degli sforzi (la scienza) degli uomini al volere divino (la fede) approderà a ben altra conclusione mettendo sé stesso al servizio dell’azione umana fino al sacrificio della vita. Leggiamo due brani significativi a sostegno di questa affermazione. “Il Padre, qui, riprese con maggiore ampiezza l’immagine patetica del flagello; evocò l’immensa trave di legno che roteava al di sopra della città, colpiva a caso sollevandosi sanguinante, e infine sparpagliava il sangue e il dolore umano < per le sementi che prepareranno le messi della verità>“ (pag. 75 dell’edizione Tascabili Bompiani). E più avanti al volgere dell’epidemia, nella seconda predica padre Paneloux afferma che “non bisognava tentare di spiegarsi lo spettacolo della peste, ma cercare di imparare quello che si poteva impararne”. Commenta il dottor Rieux che assiste all’orazione: “Gli sarebbe stato facile dire che l’eternità di delizie che aspettavano il bambino (morto per peste tra indicibili sofferenze ndr) potevano compensarlo della sofferenza, ma, in verità, lui non ne sapeva niente. Chi poteva affermare, infatti, che l’eternità di una gioia possa compensare un attimo del dolore umano? Non sarebbe sicuramente un cristiano, il cui Maestro ha conosciuto il dolore nelle membra e nell’anima” (pagg 172- 173).
 Il “pellegrinaggio” del Papa a via del Corso suscita dei commenti all’interno degli ambienti vaticani, e non solo, come testimonia il piccolo brano di un articolo di Avvenire (17 marzo) che qui riprendo. “Per chi avrà pregato domenica il Papa davanti all’icona della Salus Populi Romani a Santa Maria Maggiore e al Crocifisso miracoloso di San Marcello al Corso? Pensieri che resteranno raccolti nel suo cuore. Così come resterà impresso nell’affetto della gente il doppio “a tu per tu”, che Francesco si è concesso, uscendo a sorpresa dal Vaticano e percorrendo anche un pezzo a piedi nella deserta via del Corso, di solito una delle strade più trafficate. Tuttavia, mentre l’immagine che lo ritrae al centro della capitale è già diventata la foto simbolo della Chiesa al fianco di chi soffre per questa pandemia, non è difficile ipotizzare che in cima alle sue orazioni ci siano state tutte quelle categorie che giorno per giorno egli ricorda nella Messa di Santa Marta trasmessa in streaming”. Assumiamo questa come l’interpretazione autentica del gesto del Pontefice. A ulteriore testimonianza il giorno successivo lo stesso Avvenire torna sull’argomento, facendo scendere in campo addirittura monsignor Nunzio Galantino. Il presidente dell’Apsa e già segretario della Cei sottolinea “Un gesto sorprendente. Fatto nel rispetto di quanto opportunamente chiesto dalle autorità governative. Recandosi a Santa Maria Maggiore e a San Marcello, papa Francesco ha portato simbolicamente con sé tutta l’umanità ai piedi del Crocifisso e della Madonna”. All’intervistatore che gli ricorda le perplessità espresse da qualcuno su un gesto che poteva apparire come una sfida alle prescrizioni, Galantino precisa che si tratta di un gesto di preghiera, simbolico, fatto a nome di tutti e come “anche i simboli, in questo momento, servono a tenere desta la speranza”.
Il “pellegrinaggio” del Papa a via del Corso suscita dei commenti all’interno degli ambienti vaticani, e non solo, come testimonia il piccolo brano di un articolo di Avvenire (17 marzo) che qui riprendo. “Per chi avrà pregato domenica il Papa davanti all’icona della Salus Populi Romani a Santa Maria Maggiore e al Crocifisso miracoloso di San Marcello al Corso? Pensieri che resteranno raccolti nel suo cuore. Così come resterà impresso nell’affetto della gente il doppio “a tu per tu”, che Francesco si è concesso, uscendo a sorpresa dal Vaticano e percorrendo anche un pezzo a piedi nella deserta via del Corso, di solito una delle strade più trafficate. Tuttavia, mentre l’immagine che lo ritrae al centro della capitale è già diventata la foto simbolo della Chiesa al fianco di chi soffre per questa pandemia, non è difficile ipotizzare che in cima alle sue orazioni ci siano state tutte quelle categorie che giorno per giorno egli ricorda nella Messa di Santa Marta trasmessa in streaming”. Assumiamo questa come l’interpretazione autentica del gesto del Pontefice. A ulteriore testimonianza il giorno successivo lo stesso Avvenire torna sull’argomento, facendo scendere in campo addirittura monsignor Nunzio Galantino. Il presidente dell’Apsa e già segretario della Cei sottolinea “Un gesto sorprendente. Fatto nel rispetto di quanto opportunamente chiesto dalle autorità governative. Recandosi a Santa Maria Maggiore e a San Marcello, papa Francesco ha portato simbolicamente con sé tutta l’umanità ai piedi del Crocifisso e della Madonna”. All’intervistatore che gli ricorda le perplessità espresse da qualcuno su un gesto che poteva apparire come una sfida alle prescrizioni, Galantino precisa che si tratta di un gesto di preghiera, simbolico, fatto a nome di tutti e come “anche i simboli, in questo momento, servono a tenere desta la speranza”.
ARMATI DI SCIENZA E FEDE titola il giorno successivo Avvenire. Il dilemma si ricompone su un terreno molto solido che verrà plasticamente interpretato dal Papa, nella sua ieratica solitudine, in occasione della benedizione urbi et orbi impartita il 27 marzo in una piazza San Pietro deserta.
Avviciniamoci ora alla produzione artistica dello scrittore senza trascurare i suoi reportage giornalistici, i lavori per il teatro e la sua partecipazione incessante al dibattito pubblico del tempo.
L’uomo gettato nel mondo, avrebbero detto gli esistenzialisti, l’uomo di fronte a una vita che non ha un senso, l’uomo costantemente in balia di un evento esterno che senza motivazione può essere annientato, l’uomo sempre sulla soglia della morte. Non solo La Peste ma tutta l’opera di Camus mette al centro l’uomo, nella sua irrilevanza ma anche nella sua grandezza. La casualità dell’essere nel mondo non solo non genera alcuna forma di pessimismo o di distacco ascetico dalla vita ma esalta proprio l’amore, per sé e per gli altri, l’immersione di sé nella natura in una simbiosi estatica. L’esserci qui e oggi, la passione per la politica, la lotta a fianco di chi soffre, il desiderio e l’amore appaganti. A sostegno di tutta questa architettura di valori c’è qualcosa di ancora più profondo, il fondamento ultimo, l’uomo. In due celebri passi de La Peste, il primo nel momento del manifestarsi dei segni della malattia e il secondo nell’infuriare della stessa. Il dottor Rieux nella sua saldezza razionale inquadra con lucidità la situazione: ”Quello che bisognava fare era riconoscere chiaramente quello che doveva essere riconosciuto, cacciare infine le ombre inutili e prendere le misure necessarie. […..] Il dottore aprì la finestra, il brusio (in francese bruit) della città si accrebbe all’improvviso. Da un’officina poco distante saliva il sibilo breve e ripetuto di una sega meccanica, Rieux si scosse: là era la certezza, nel lavoro di ogni giorno. Il resto era appeso a fili e a movimenti insignificanti, non ci si poteva fermare. L’essenziale era far bene il proprio mestiere”. E più avanti in un altro passaggio fondamentale dell’opera: “Che cos’è l’onestà” disse Rambert con aria improvvisamente seria. Il medico risponde: “Cosa sia in genere, non lo so; ma nel mio caso so che consiste nel fare il mio mestiere”. Ecco, l’uomo che fa bene il proprio mestiere è l’uomo che vive. Nell’indeterminatezza delle cose, nel flusso incontrollabile dell’esistenza, scevro da ideologie e religioni, l’uomo ha una sola ancora di salvezza: questo saldo principio morale. Non c’è niente di prometeico, di straordinario, di eroico nell’uomo di Camus. In un altro di quei dialoghi in cui lo scrittore franco-algerino distilla la sua visione del mondo, in questo caso in risposta a Tarrou, l’interlocutore con il quale nel dispiegarsi della lotta al morbo si cementa una autentica e profonda amicizia, Bertrand Rieux afferma: “Ma lei sa, io mi sento più solidale coi vinti che coi santi. Non ho inclinazione, credo, per l’eroismo e per la santità. Essere un uomo, questo mi interessa”. La grandezza dell’uomo sta insomma nella sua normalità.
Ho avuto già modo di fare riferimento all’intenso rapporto che Camus mantenne sempre con Tipasa. In verità fu il suo rapporto con la terra natale, l’Algeria, a attraversare tutta la sua vita, ma qui il discorso sarebbe molto più ampio e con grandi implicazioni politiche che, se ci riusciremo, riprenderemo più avanti. Limitiamoci ora a Tipasa. L’evidenza maggiore di questa relazione l’abbiamo in particolare attraverso il primo racconto di Noces. Va ricordato che questi lavori risalgono al periodo 1936/37, quando l’autore aveva ventitre anni, e vennero sempre da lui considerati come degli essais, prove studi esperimenti insomma, e come ci ricorda la nota dell’editore, essais nel senso esatto e limitato del termine. Quasi che dovessero rappresentare materiali per rielaborazioni successive e chissà se così in effetti non sarebbe stato senza il tragico incidente d’auto. L’amore, il desiderio, la sensualità, la simbiosi con la natura, questi elementi traboccano, in alcuni casi in modo incontenibile, da quelle pagine giovanili. L’uomo gettato nel mondo, in un’esperienza esistenziale priva di senso e direzione, non è però mai solo. In un duplice senso. Perché sta sempre dalla parte delle vittime “in ogni occasione, per limitare il male” [La Peste pag 196]. Lui che viene dal nulla, da una famiglia poverissima, senza padre, e come ci ricorda in un passo de “Il primo Uomo” “… dichiarando che sarebbe andato al ristorante, un locale dove non aveva mai messo piede, come del resto nessuno della famiglia, anche se la nonna, ogni volta che a tavola si levavano parole di malcontento, non mancava mai di pronunciare la frase fatidica < Va’ al ristorante > “. O quando Rieux rivendica la sua origine sociale “un figlio di operaio come me”. Con i più deboli, con le vittime si sta per limitare il male ma anche per condividere la felicità, perché “ci può essere vergogna nell’essere felici da soli” [pag 161]. La felicità quindi come obiettivo dell’uomo che fonda tutto su sé stesso e sulla sua moralità, al tempo stesso però una condizione esistenziale da condividere con gli altri. Secondo, l’uomo non è comunque solo perché si compenetra con la natura. Ai piedi del faro (di Tipasa) “grosse piante grasse dai fiori viola, gialli e rossi scendono verso le prime rocce che il mare succhia con il rumore di baci”. La musicalità della lingua francese rende di più la fisicità cromatica di questa descrizione, della quale va sottolineato l’uso di due termini “bruit” e “suce”. Il rumore, il brusio è lo stesso che Camus usa quando ne La Peste apre la finestra per ascoltare il rumore di Orano, l’attività lavorativa, il pulsare dell’attività dell’uomo. Con il termine “suce”, succhia, si vuole maliziosamente insistere su una sorta di erotizzazione del rapporto con la natura, essendoci piena corrispondenza tra italiano e francese nell’uso diciamo così, estensivo, del termine. E più avanti, quando nudo si tuffa nel mare in una sorta di abbandono e di dissolvimento con l’ambiente liquido, il corpo profumato delle essenze della terra per lavarle in quelle del mare, in una estatica condizione in cui “stringere sulla mia pelle l’abbraccio con cui sospirano bocca a bocca da così tanto tempo la terra e il mare”. Proseguendo in questa metaforica congiunzione erotica in cui terra, mare, natura, uomo si possiedono reciprocamente e si fecondano. “Io comprendo qui ciò che viene chiamata gloria: il diritto di amare senza misura. Non c’è che un solo amore nel mondo” e, pare di capire, sta in questo indissolubile legame dell’uomo nell’universo naturale. Fino alla conclusione, in cui quasi in un grido orgasmico Camus scrive: “Abbracciare un corpo di donna è come tenere contro di sé questa gioia inquietante (così va tradotto a mio giudizio “étrange”) che discende dal cielo verso il mare”. È come se in questo abbraccio si ricomponesse un’armonia cosmica in cui l’uomo ritrova la sua collocazione naturale, sballottato com’è tra, da una parte, la ineluttabilità delle cose, la irragionevolezza della vita – per cui Mersault il protagonista de Lo Straniero può scendere in spiaggia e sparare a un arabo, così senza ragione, forse solo perché il calore del sole è troppo opprimente – e, dall’altra, il rigore morale, fondamento della libertà dell’uomo, che lo pervade in quella sorta di kantismo pratico come lo ha definito Bernard-Henri Levy. Ma questa armonia non è mai data una volta per tutte. È una ricerca continua, un divenire costante, un equilibrio che tenta di ricomporsi. Essa ha come compagno di strada inseparabile il desiderio, che al tempo stesso la mina e la ricompone. Camus ama le donne e ama essere amato. Sartre nel momento della rottura – lo vedremo più avanti – non gli risparmierà nella sua perfidia neanche questo, manifestando il suo disappunto per questo “furfantello algerino” che corteggia tutte le donne che incrociano la sua strada. Non possiamo stupirci che il dissidio tra grandi intellettuali, che sono pur sempre uomini desiderosi di conquista femminile – Sartre non era certo un adone ma spopolava con le donne – finisca anche per coinvolgere l’invidia e la competitività maschilista. Camus avrà costante bisogno nella sua breve vita di un’interlocuzione nel senso più ampio del termine con l’altro genere. Due matrimoni, uno nel 1934 con Simone Hié (finirà appena due anni dopo) e uno nel 1940 con Francine Faure, un amore profondo e duraturo con Maria Casarès, forse più di una moglie, non gli impediranno di mantenere altre relazioni. L’approccio sensuale alla natura è anche l’approccio sensuale alla vita in cui desiderio spirituale e desiderio carnale si incrociano e si completano vicendevolmente. “Noces à Tipasa” è il contenitore, a volte in forme che sfiorano l’immagine barocca, più espressivo di una sensualità pervasiva come vettore dell’armonia tra uomo e natura. L’incipit del racconto lascia senza fiato. Lo riportiamo nell’originale: ”Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil”.
Dell’importanza della componente femminile sono peraltro testimonianza i ruoli che rivestono nella vita dello scrittore franco-algerino le figure della nonna e della madre. La prima, domina assoluta dell’organizzazione familiare, vero pater familias, ruvida, dispotica, a tratti rozza, dispensa punizioni e castighi, intenta soltanto a amministrare i rari denari che possano consentire alla famiglia di mantenersi appena al di sopra della linea dell’indigenza. Ostile persino alle esigenze e agli impegni scolastici e formativi che pure le evidenti qualità del nipote esigono. La madre, invece, donna dolcissima non ha parola e tanto meno linguaggio, totalmente succube dei voleri materni. Fiera di questo figlio, minato nel fisico dalla tubercolosi, ma di evidente e palpabile straordinarietà. In occasione della conferenza stampa per il conferimento del premio Nobel, il suo Albert si esprimerà in modo stupefacente, affermando che nessuna causa nemmeno la più giusta lo potrà sganciare, dissociare (il termine francese è desolidariser, ed è ancora più forte) da sua madre “qui est la plus grande cause que je connaisse au monde”.
 Per concludere su questo aspetto del rapporto sensuale con la natura e con l’universo umano, è opportuno ricordare la funzione che svolge l’immersione nell’acqua del mare. Abbiamo ricordato sopra come sulla spiaggia di Tipasa l’autore si immerge nudo nelle acque per essere parte dell’abbraccio tra terra e mare. Troviamo un passo altrettanto significativo ne La Peste quando a suggello dell’amicizia che si costruisce tra Rieux e Tarrou nel fuoco della battaglia contro l’epidemia. “Sa cosa dovremmo fare per l’amicizia?” disse. “Quello che lei vuole” disse Rieux. “Un bagno in mare”. I due amici si dirigono quindi al porto. “Il mare ansava dolcemente ai piedi dei grandi blocchi del molo, e quando li ebbero superati, apparve spesso come un velluto, flessibile e liscio come una belva”. Una volta in acqua i due uomini presero a nuotare “Per alcuni minuti procedettero con la stessa cadenza e con lo stesso vigore, solitari, lontani dal mondo, finalmente liberati dalla città e dalla peste”. Uscirono alla fine dall’acqua senza scambiarsi una parola, “ma avevano lo stesso cuore”. Il mare è l’apertura, il rifiuto di un piccolo universo chiuso in sé stesso, il desiderio che si appaga nel profumo e nella dolce liquidità dell’armonia.
Per concludere su questo aspetto del rapporto sensuale con la natura e con l’universo umano, è opportuno ricordare la funzione che svolge l’immersione nell’acqua del mare. Abbiamo ricordato sopra come sulla spiaggia di Tipasa l’autore si immerge nudo nelle acque per essere parte dell’abbraccio tra terra e mare. Troviamo un passo altrettanto significativo ne La Peste quando a suggello dell’amicizia che si costruisce tra Rieux e Tarrou nel fuoco della battaglia contro l’epidemia. “Sa cosa dovremmo fare per l’amicizia?” disse. “Quello che lei vuole” disse Rieux. “Un bagno in mare”. I due amici si dirigono quindi al porto. “Il mare ansava dolcemente ai piedi dei grandi blocchi del molo, e quando li ebbero superati, apparve spesso come un velluto, flessibile e liscio come una belva”. Una volta in acqua i due uomini presero a nuotare “Per alcuni minuti procedettero con la stessa cadenza e con lo stesso vigore, solitari, lontani dal mondo, finalmente liberati dalla città e dalla peste”. Uscirono alla fine dall’acqua senza scambiarsi una parola, “ma avevano lo stesso cuore”. Il mare è l’apertura, il rifiuto di un piccolo universo chiuso in sé stesso, il desiderio che si appaga nel profumo e nella dolce liquidità dell’armonia.
Lo stile, il linguaggio, persino la sintassi dello scrittore algerino finiscono per costituire una tela di ragno dentro alla quale il lettore viene irretito in un gioco di stimolazione e appagamento. A più riprese la scrittura assume le forme di un turgore quasi fisico nei colori, negli odori e nei sapori che sembrano entrare nei nostri organi sensoriali. La luce, il calore, l’esplosione primaverile della vita ci appaiono come il turgido capezzolo di un seno che si espone alla nostra attenzione. In queste parti della sua opera, mi si perdoni questa espressione che potrebbe apparire blasfema, Camus attinge il livello di un erotismo raffinatissimo che è inscritto indelebilmente nel suo dna mediterraneo. È quella componente della sua personalità che in qualche modo Sartre prima gli rinfaccia come “mesure meditirranéenne “nel vivo della polemica politica e poi nell’orazione funebre coglie invece benissimo come “humanisme sensuel”.
C’è una domanda che alla fine non può non sorgere alla nostra consapevolezza. L’umanesimo radicale di Camus, l’uomo come pietra miliare di ogni giudizio, la rivendicazione della assoluta indifferenza a ogni ideologia, la libertà contro tutto e contro tutti, un ateismo che tocca momenti di paganesimo, non finiscono per porre l’individuo su un piedistallo in distacco dal fluire a volte meschino delle umane cose? Non ne definisce un profilo eroico e prometeico? Abbiamo visto sopra, come lo scrittore affermi la sua avversione a ogni forma di eroismo e santità, ponendo l’accento sulla normalità. E bisogna prenderne atto. Ma la questione resta, quanto in questa rigorosità suprema si affaccia lo spettro del superuomo? Quali sono i rapporti tra il pensiero dello scrittore con le teorie nietzschiane? È noto come tutto l’ambiente culturale parigino – di cui Camus entrò a fare parte organicamente al suo arrivo nella capitale nel 1940 e ancor di più nel 43 quando diventa lettore presso la casa editrice di Gallimard – fosse sostanzialmente monopolizzato dall’esistenzialismo. Lo stesso esistenzialismo era attraversato non solo da polemiche politiche violentissime ma anche da riferimenti teorici articolati. Abbiamo Camus e Sartre, ma altri personaggi di altissima levatura marcavano la scena culturale dell’epoca in Francia. Breton, Malraux, Koestler, de Beauvoir, Lacan, Merleau-Ponty, Aron e Lévinas solo per citare i maggiori. E quanto fosse grande il tributo teorico che, nolenti o volenti, il movimento esistenzialista doveva alla fenomenologia di Edmund Husserl e a Martin Heidegger appare evidente. Scrive Sarah Bakewell nel suo libro del 2016 “Al caffè degli esistenzialisti”: “Nietzsche e Kierkegaard furono i precursori dell’esistenzialismo moderno; furono i pionieri di un sentire incline alla ribellione e all’insoddisfazione, crearono una nuova definizione dell’esistenza intesa come scelta, azione e autoaffermazione, e studiarono l’angoscia e la difficoltà di vivere. Inoltre portarono avanti la propria opera convinti che la filosofia non fosse solo una professione. Questa era la vita stessa: la vita di un individuo”. A questo punto, però, a me mancano gli strumenti per continuare in questo approfondimento e non mi resta che rivolgermi ai miei amici filosofi. C’è comunque un dato storico che va richiamato. Camus si misurò a più riprese con l’opera di Nietzsche e lo fece all’interno di un clima più generale di una certa intellettualità francese che nel dopoguerra pensò di “ripulire” il filosofo tedesco e di strapparlo al nazismo. Ma ripeto, qui mi fermo. Posso solo aggiungere, come piccola suggestione, che sono le condizioni materiali, l’esperienza di vita e le sue origini, che “salvano” lo scrittore algerino mantenendolo saldamente su un terreno democratico e coerentemente antifascista. Cosa intendo dire? Proprio la concezione della filosofia come vita, il richiamo all’ “impegno” nel mondo portano a far prevalere la materialità della vicenda umana, individuale e collettiva, rispetto a ogni fascinazione intellettuale. Camus nella sua pur breve vita ha conosciuto tre guerre: la Grande Guerra che gli porta via il padre che lui non ha mai conosciuto; la Seconda guerra mondiale a cui non prese parte per la tubercolosi che lo minava e di cui denunciò con parole vibranti il bombardamento atomico di Hiroshima; la guerra d’Algeria. Tre avvenimenti storici – più di venti anni “d’une histoire démentielle” come ebbe a dire a Stoccolma in occasione del Nobel – che lo segnarono nel profondo e che ne definirono la personalità. Camus, inoltre, nella seconda metà degli anni trenta non compone soltanto le splendide pagine su Tipasa di cui abbiamo a lungo parlato. È anche grande giornalista di reportage sulle drammatiche condizioni di vita della Cabilia nella sua Algeria. Il suo essere dalla parte dei deboli non è un atteggiamento compassionevole, ma lo spinge a una denuncia sociale veemente con la vera arma che ha a disposizione, la scrittura. E persino, su un piano assai diverso, la sensualità esistenziale che pervade il suo essere, proprio per la sua profondità, presuppone e implica un profondo rispetto e riconoscimento dell’oggetto del desiderio, sia esso persona o cosa. Per non dire poi della sua inflessibile battaglia per l’abolizione della pena di morte. Insomma, non c’è categoria morale e politica più estranea allo scrittore franco-algerino di quella della “volontà di potenza”. Qui c’è davvero un fossato. Lo testimonia, ove ce ne fosse ancora bisogno, una delle ultime pagine de La Peste che trasuda di calore umano, persino di tenerezza e di “ordinarietà”. Riferendosi a coloro che dopo il calvario dell’epidemia avevano ritrovato la persona amata e lontana (privilegio che non viene riconosciuto a Rieux che perde la moglie in un lontano sanatorio) il medico riflette: “Per qualche tempo, almeno, sarebbero stati felici; ora sapevano che se una cosa si può desiderare sempre e ottenere talvolta, essa è l’affetto umano”. Ancora: “Rieux (…) ritenne giusto che, almeno di tanto in tanto, la gloria venisse a ricompensare quelli che si accontentano dell’uomo e del suo povero, terribile amore”. Il “povero terribile amore” ci rimanda a tutto tondo la figura di questo umanista integrale, pervaso di sensualità, che respira all’ unisono con la natura e con le sofferenze dei più deboli.
In occasione della ricorrenza del quarantennale della morte (2010) dello scrittore, Le Monde gli ha dedicato un’Hors-série, di ottima fattura, intitolato “Albert Camus la rivolta e la libertà”. La parte predominante dell’opuscolo è occupata da un saggio di Bernard-Henry Lévy dal titolo significativo “Un filosofo artista”. La tesi di fondo, viziata a mio giudizio da un’eccessiva posizione anti Sartre, sta nel voler riconoscere a Camus una sorta di patente da filosofo. Ora a me pare un esercizio un po’ capzioso e francamente inutile. Non ha molto senso mettersi a misurare i quarti di nobiltà filosofica di uno scrittore che rappresenta una delle vette della letteratura del Novecento. Un artista nel senso più pieno del termine. Così come gli si farebbe torto se lo guardassimo “a pezzi”, lo scrittore, il giornalista, il politico, il moralista etc. Camus senza dubbio è tutto questo, ma il totale non è la somma. C’è qualcosa di più e in questo caso c’è molto di più. Un di più che possiamo cogliere solo se ci rivolgiamo a Camus come Camus. Vogliamo dirlo: all’uomo!
Il movimento esistenzialista nelle sue varie articolazioni, filosofica politica di costume, portò una ventata d’aria fresca nella cultura e nelle società degli anni 50. Il suo contributo ai moti che caratterizzarono i successivi anni 60 fu senza dubbio di grande rilevanza. L’attitudine a mettere in discussione tutto ciò che è costituito, la spinta a affermare un altro punto di vista sulle cose del mondo, l’assumere l’individuo come il “benchmark ultimo” su cui misurare l’esistenza, rappresentano il prerequisito degli sviluppi libertari del decennio successivo. La carica antiautoritaria che segnerà fino alle più estreme conseguenze la contestazione sessantottesca trova senz’altro lì una fonte di alimentazione. Ancora una volta sarà la confluenza tra filosofia tedesca e politica francese a rappresentare l’innesco di quella grande stagione di liberazione. Ma è questo un terreno su cui non posso avventurarmi. Camus vive e interpreta pienamente fino alla sua morte quelle tematiche apportandovi un contributo significativo. La libertà dell’individuo che prende totalmente in mano la sua vita, con il modernissimo sentimento di angoscia che ne discende, e esercita quella libertà in mezzo a altri uomini che hanno lo stesso diritto di vivere la vita richiede il dispiegarsi di un grande movimento di liberazione. Che è liberazione individuale, sociale, ma anche nazionale. Ci avviciniamo così alla grande contraddizione che attraversa, irrisolta, la vicenda dello scrittore franco algerino: il suo atteggiamento nei confronti della lotta di liberazione dell’Algeria. In una visione politicamente coerente con quel sistema di pensiero lo schierarsi a fianco delle rivendicazioni del popolo algerino sarebbe addirittura un automatismo. Tanto più nel vivo del dispiegarsi nella seconda metà degli anni 50 del fenomeno della decolonizzazione. Per Camus non è così. Perché? La questione è ancora più complessa perché Camus è in linea di principio favorevole ai processi di liberazione nazionale. Prendiamo le mosse dal presupposto che lui è un uomo di due mondi. È al tempo stesso algerino e francese, nessuna di queste componenti è scindibile, pensabile a sé. Ma nemmeno componibile in una sintesi superiore. Solo nella creazione letteraria, nel punto più alto del suo essere artista, i due filoni si fondono nella trasfigurazione narrativa. Camus si illuderà tra il 1954 – anno in cui prende il via la rivolta algerina – e il 1958 – anno in cui si ritirerà dal dibattito pubblico sull’argomento, consapevole della debolezza delle sue argomentazioni – di poter raggiungere la stessa sintesi a livello politico. Che altro è, infatti, la sua proposta di una sorta di federazione tra Francia e Algeria o di uno stato binazionale, come qualcuno ha detto – se non il tentativo di portare a sintesi istituzionale lo scontro tra i colonizzatori e gli indipendentisti? La posizione appare immediatamente come astratta e avulsa dal concreto dipanarsi degli accadimenti storici. C’è qualcosa insomma che vela la capacità di analisi dello scrittore franco-algerino o algerino-francese. Ed è qualcosa, mi sento di dire, di ancestrale, di primitivo, di arcaico. Senza ascrivere nessun significato negativo a questi aggettivi. Il primo aspetto, meno rilevante, riguarda la sua critica radicale alla pratica del terrorismo. Camus ha meditato a lungo sull’argomento per arrivare a definirlo, a ragione, come nemico della democrazia e come una specie di prodotto del totalitarismo. Egli ritiene che nella sua terra d’origine il terrorismo sia il frutto de “l’absence d’espoir”, della mancanza di ogni possibilità di un avvenire. È espressione dell’odio e conduce al razzismo. Non credo, però, che questa critica alla forma di lotta terroristica all’interno del processo di indipendenza – metodo tra l’altro praticato da tutte e due le parti contendenti e quindi non ascrivibile esclusivamente ai combattenti algerini – possa rappresentare la motivazione di fondo. C’è dell’altro e a un livello assai più coinvolgente la complessa personalità dello scrittore. Il rapporto tra Camus e l’Algeria non si situa a livello di razionalità storico politica, di valutazione delle concrete circostanze storiche che muovono il sentimento di un popolo. È piuttosto un movimento dell’anima, un sostrato di radicamento psicologico, una componente del rapporto con la natura. In questo senso confina con le caratteristiche del legame con la madre. Abbiamo già visto come in occasione del conferimento del Nobel, Camus abbia detto che nulla avrebbe mai potuto staccarlo dalla madre che era la causa più giusta che egli conoscesse al mondo. Una madre analfabeta, parzialmente sorda, che conosceva sì e no quattrocento parole, unico soggetto “totalizzante” di fronte al quale si inchinasse. E l’Algeria è, potremmo dire, la sorella minore di questa madre. L’Algeria è la sensualità, i colori, la natura, la terra, il mare, il cielo, Tipasa, la Kabilia degli ultimi. È un legame che non si può spezzare. E in qualche modo l’indipendenza potrebbe mettere a rischio questo legame perché l’Algeria nella sua grandezza irrevocabile è, come la madre, un soggetto debole. Lasciata a sé stessa potrebbe generare una dittatura, un’entità non più totalizzante ma totalitaria

Quale spendibilità politica nel dibattito pubblico così infuocato potesse avere una posizione che si portava dietro un fardello così pesante è facile immaginare. L’inesplicabile non può essere argomentato, allora meglio gettare la spugna, lasciar parlare il silenzio. Una sconfitta? Sì certo. Un’incapacità a saper valutare le circostanze e le forze in campo, in altri termini a saper stare nella storia? Senza dubbio. Resta a noi, però, la limpida naiveté dell’uomo Camus, dell’artista.
In questa ottica anche il Mediterraneo gioca un ruolo diverso da quello che gli viene riconosciuto tradizionalmente. Senza dubbio da un punto di vista anagrafico e dello sviluppo della sua personalità di uomo pubblico è il Mediterraneo a rappresentare il trait d’union della sua vita. Potremmo dire sia per l’andata che per il ritorno. Il padre Lucien è un pied noir, come si dice dei francesi trapiantati in Algeria, discendente di una famiglia di origini alsaziane, modesto operaio di una azienda di produzione di vini, tornerà in Francia solo per essere ammazzato nella battaglia della Marne nel 1914 senza avere mai visto suo figlio. La madre è di origini spagnole. Albert nasce nella sperduta provincia algerina per trasferirsi piccolo a Algeri, dove si forma prima al Liceo per ottenere poi la laurea in filosofia. Nel 1940 sbarca a Parigi dove resta un anno per ritornare a Orano come insegnante. Alla fine del 42 torna nella capitale francese dove resterà fino alla morte. Un percorso non molto diverso da quello di tanti che, sotto tutte le latitudini, nati da umili origini sono costretti a emigrare verso il “centro” per affermare il proprio profilo personale, sia esso professionale o artistico. Camus non taglierà mai le sue radici e in questo senso può essere considerato un uomo di due mondi, come l’ho sopra definito. Anche al vertice della sua fama, però, egli verrà considerato un “estraneo” dal club degli intellettuali parigini che, a prescindere dalle appartenenze politiche, si configura comunque come una cerchia ristretta. Si farà largo tra di loro con grande successo ma non perderà mai ai loro occhi una patina da parvenu. Ben altro standing rivestono Sartre e de Beauvoir! E Sartre non gli risparmierà la spada, altroché fioretto, quando nel vivo della polemica tra i due gli rinfaccerà la sua umile origine e la sua povertà. In questa ottica il Mediterraneo svolge il suo ruolo secolare di facilitatore degli interscambi commerciali e culturali. Ben altro significato esso assume, a mio giudizio, se lo guardiamo dal punto di vista della poetica e dell’immaginario spirituale dello scrittore. Il Mediterraneo non è, come diceva Fernand Braudel, un mare che unisce, ma nella poetica di Camus è tutt’uno con l’Algeria. È la natura e la sensualità, i riflessi che guizzano sulla sua superficie non sono quelli della Francia ma quelli dell’Africa.
Veniamo, infine, alla questione più squisitamente politica che a più riprese ha già fatto capolino in queste note: il rapporto tra Camus e Sartre. La militanza di Albert nelle file del Partito Comunista d’Algeria è un’esperienza che si consuma nell’arco di due anni. Si iscrive nel 1935, diventa segretario della Casa della Cultura di Algeri all’inizio del 37 e nel corso dello stesso anno si dimette dal partito. La sua partecipazione al dibattito pubblico algerino e francese crescerà in modo esponenziale con la fondazione di riviste, attività giornalistica, polemiche politiche, prese di posizione su vari argomenti, fino a farne uno dei più influenti se non il più influente intellettuale per quasi due decenni dal dopoguerra al millenovecentosessanta. Insomma, la fuoriuscita da un partito politico non fece venire meno il suo “ingaggio” su tutti i grandi temi che attraversavano la sua epoca. Tutt’altro. Abbiamo cercato di mettere in evidenza alcuni aspetti del pensiero e dell’opera dello scrittore, la sua personalità complessa e tormentata, il suo riferimento insopprimibile all’uomo come fondamento del suo universo ideologico, la libertà individuale come punto d’appoggio della leva dell’esistenza. Può una personalità come questa essere ricondotta all’interno di un orizzonte strettamente politico e per di più partitico? Ancor più in un contesto di rigidità ideologica, politica, dottrinale come quello di quel tempo. La risposta è nelle premesse prima ancora che nello svolgimento degli avvenimenti come si sono storicamente determinati. I due protagonisti furono a lungo uniti dalla comune volontà di lottare per l’affermazione della giustizia sociale e di stare sempre e comunque dalla parte dei deboli. Per Sartre tutto questo coincideva con il comunismo e il comunismo con il sistema instaurato in Unione Sovietica. Era così, e poco spazio c’era per le anime belle. L’emergere dei crimini di Stalin, l’orrore dei gulag dovevano essere accettati, seppur non condivisi, all’interno di un processo rivoluzionario il cui esito sarebbe stata la liberazione dalla schiavitù capitalistica. C’erano questioni di fondo dietro a queste laceranti contrapposizioni. Il ruolo della violenza nell’azione rivoluzionaria, la vocazione totalizzante (totalitaria?) a un ideale, la libertà individuale come fondamento di una società giusta. Lo scontro era nelle cose. Ma era lo scontro non tra due uomini granitici ma tra due uomini lacerati. Le lacerazioni dello scrittore abbiamo provato a descriverle sopra e, per quanto riguarda in particolare la politica, si manifestarono in modo plateale nel suo irrisolto rapporto con l’Algeria e la sua guerra d’indipendenza. A proposito di Sartre basti dire della palese contraddizione tra il filosofo esistenzialista che predicava la libertà assoluta dell’individuo nel mondo e il politico marxista che accettava l’amputazione di questa libertà nel fluire concreto del processo storico. Camus aborriva, come abbiamo visto, ogni forma di violenza terroristica che riteneva non solo una ferita della democrazia ma una filiazione diretta del totalitarismo. Sul piano più teorico, nella sua visione di moralismo assoluto, poneva l’accento sulla responsabilità per l’uomo di vivere in maniera autentica la libertà di cui disponeva. Sartre dalla sua collocazione alto borghese poteva degnarsi di un cinismo condiscendente verso la violenza e gli attori che la praticavano, Camus nella sua umile provenienza restava tetragono a difesa della coerenza e del rifiuto comunque della violenza. Il primo incontro tra i due avvenne nel 1943 al teatro Sarah Bernhardt di Parigi, dove Camus si presentò per assistere alle prove della pièce Le Mosche scritta da Sartre. La stella del filosofo brillava ormai da tempo nel firmamento intellettuale, da quando nel 1938 era divenuto famoso con la pubblicazione de La Nausea. Non si conoscevano personalmente ma erano noti l’uno all’altro in quanto Albert aveva già pubblicato una recensione a La Nausea e il filosofo stava scrivendo la sua a Lo Straniero. Stando alla testimonianza di Simone de Beauvoir ci fu immediata simpatia, sottolineata dall’apprezzamento di Sartre per l’”anima semplice, allegra” e l’emotività di Camus. Come si può notare, traspare da queste confidenze tra Simone e Jean Paul una certa dose di sufficienza per non dire albagia nei confronti dell’algerino, tipica dei due grandi sacerdoti dell’intellettualità parigina. Comunque la relazione si sviluppò in modo importante negli anni successivi anche con una componente di calore umano e di vicinanza culturale. Tra l’altro Sartre negli anni Quaranta era molto concentrato sul tema della libertà dell’uomo e questa ricerca favoriva la contiguità con lo scrittore. Nel 1947, che è l’anno, non dimentichiamolo, della pubblicazione de La Peste, Sartre e Camus sottoscrissero insieme un appello della rivista Esprit a sostegno di un posizionamento internazionale della Francia in assoluta autonomia dall’Unione Sovietica e dagli Stati Uniti proprio nel momento in cui andava strutturandosi la configurazione del mondo in due blocchi contrapposti. Più complessa comincia a farsi la situazione all’avvio del decennio Cinquanta. Nell’ottobre del 51 esce L’Homme Révolté in cui Camus inneggia a una sorta di rivoluzione permanente come azione creatrice che consente all’uomo di individuare e di esprimere un senso in un mondo che è dominato dal non senso, secondo la sua radicata convinzione filosofica. Sartre si era dimostrato sempre scettico nei confronti di questa visione al limite del nichilismo del suo amico e l’incalzare delle vicende politiche internazionali lo portavano a indurire le sue posizioni. Era in pieno svolgimento la guerra di Corea, il primo vero atto militare della confrontation tra i due blocchi, e forti erano le preoccupazioni che si sarebbe trasformata in un altro tragico conflitto mondiale a pochi anni dalla fine della seconda guerra. Nei circoli parigini si discuteva accanitamente, fino addirittura a trascendere all’uso delle mani, sull’ipotesi che in questo contesto la Francia potesse essere oggetto di invasione da parte dei sovietici. Facendo emergere drammaticamente la questione delle questioni, quella della doppia fedeltà. Vale a dire, cosa avrebbero fatto i francesi sostenitori della causa comunista: sarebbero rimasti fedeli al loro ideale incarnato dagli invasori o si sarebbero convertiti alla causa patriottica? La lacerazione raggiungeva livelli altissimi, anche per l’opera oscura di soggetti infiltrati che alimentavano la tensione e operavano liste di proscrizione in un campo e nell’altro. Ma torniamo agli aspetti più squisitamente culturali. La posizione di Camus è come al solito granitica, la rivolta è ciò che ci consente, spingendoci a guardare dentro noi stessi, di imparare a comportarci, a dare un senso al nostro stare nel mondo. “La solidarietà degli uomini si basa sul movimento di rivolta”. C’è solo un limite che si pone di fronte all’uomo in rivolta “accettare di uccidere sé stesso per rifiutare la complicità con l’omicidio in generale”. Come sappiamo il Ventesimo secolo è attraversato anche filosoficamente dal problema della violenza. Il secolo tragico che ha lasciato sul terreno in trenta anni più morti di tutta la storia dell’umanità vive faccia a faccia con il tema dell’uso e della finalità della violenza. Il dilemma che aveva attraversato l’animo di molti, accettare la violenza per non farsi complici della scelta di non agire. Ma al tempo stesso il rifiuto, come sappiamo fortissimo in Albert, del terrorismo e di ogni forma di omicidio. Fino al punto di sacrificare sé stesso. Per completezza della posizione di Camus non è irrilevante comunque ricordare, anche in omaggio della sua cristallina onestà, che lui stesso si renderà conto del radicalismo estremo a cui era giunto. Dopo la pubblicazione de L’Uomo in rivolta con una frase apodittica, quasi scultorea, si esprimerà così:” Rivolta, vero crogiolo degli dei. Ma essa genera anche gli idoli”. Insomma, lo scrittore si rende conto, nel momento della sua critica irreversibile, da uomo di sinistra, del marxismo e del comunismo, dell’antinomia insita nel suo ragionamento e prova a uscirne con quella che chiama la filosofia del limite. La rivolta deve essere incessantemente alla ricerca di un equilibrio, nel fuoco degli avvenimenti deve sempre rifasare sé stessa. Corre nemmeno tanto sotterraneo in questo argomentare l’insopprimibile conflitto tra morale e politica. E anche in questo caso Camus si arrocca sul terreno che sente più solido, su quelle radici che tanto splendidamente germogliano nella sua attività artistica ma non sono altrettanto prolifiche nell’analisi storico-politica: i principi morali sono il caposaldo imprescindibile. Nel calor bianco dello scontro politico, in questo punto si apre un varco nella guardia dello scrittore algerino e la spada, non il fioretto, della vecchia volpe Sartre si infila senza pietà. Anima bella!
Sartre, con altezzosità quasi sprezzante, affida nella sua rivista Les Temps Modernes a Francis Jeanson la stroncatura dell’opera dell’amico, dando il via a quella che può essere considerata la controversia culturale più famosa dell’epoca moderna. Camus non controbatte al recensore ma si rivolge direttamente a Sartre riproponendo punto per punto la sua linea e accusando, in estrema sintesi, la rivista di essere a favore “di rivoltarsi contro tutto meno che contro il partito e lo Stato comunisti” e di voler sostituire la storia con lo storicismo. Nell’agosto del 52 esce la replica di Sartre permeata in fondo dall’idea dell’inadeguatezza del pensiero dello scrittore, idea che viene in più punti esplicitata. L’attacco è duro, diretto, personale. Camus sarebbe finito “preda di un triste eccesso che maschera le tue difficoltà interiori”. Ancora, “una dittatura violenta e cerimoniosa si è installata dentro di lei che si basa su una burocrazia astratta e pretende di far regnare la legge morale”. “Lei è diventato terrorista e violento nel momento in cui la storia – che lei rifiuta – l’ha a sua volta rifiutato”. Per chiudere con frase che non ammette replica “Spero che il nostro silenzio farà dimenticare questa polemica”. È la pietra tombale sull’amicizia. Nel suo algido cinismo di uomo che sa ben distinguere, nel nome del comunismo realizzato, da quale parte occorre schierarsi nel momento in cui la storia impone di sporcarsi le mani, l’articolo di Sartre è tecnicamente perfetto. Non si vedranno più. Solo la morte dello scrittore consentirà a Sartre di liberarsi di tutte le sovrastrutture che gli ultimi anni avevano consolidato per riportare il loro rapporto alla sua essenza vera e profonda, in una orazione funebre capolavoro. Il loro dissidio, il loro litigio diventa “un altro modo di vivere insieme”, “il suo silenzio, che a seconda degli eventi e del mio umore, consideravo a volte troppo prudente e a volte doloroso, era una qualità di ogni giorno, come il calore o la luce, ma umane”. Passando poi dal piano dei rapporti personali al giudizio sull’artista:” Egli rappresentava in questo secolo, e contro la Storia, l’erede attuale di questa lunga stirpe di moralisti le cui opere costituiscono probabilmente ciò che c’è di più originale nelle lettere francesi. Il suo umanesimo testardo, rigoroso e puro, austero e sensuale, impegnava un improbabile combattimento contro gli avvenimenti enormi e deformati di questo tempo”. Per riconoscere inoltre a questo “cartesiano dell’assurdo” la sua indefettibile volontà di restare ancorato al terreno della moralità assoluta, rifiutandosi – e qui suona l’elemento di critica – di incamminarsi per le incerte strade della pratica.
Al servizio della verità e della libertà, questa la cifra a cui Albert Camus amava richiamare sé stesso. Qualcosa di non umano, di un sapore in qualche modo trascendente. Una missione più che un obiettivo programmatico dell’esistenza. Paragonabile solo alla fatica di Sisifo a cui dedicò un lavoro che potremmo definire di formazione quando non aveva ancora compiuto trenta anni. Un lavoro che gli consentì di definire già una sua posizione peculiare all’interno del movimento esistenzialista sottolineando in modo particolare il tema dell’assurdo. Una fatica quella di Sisifo che viene associata abitualmente allo sforzo inutile ma inderogabile di spingere un masso fino alla cima per vederlo inevitabilmente ritornare sempre al punto di partenza. Sinonimo quindi nell’immaginario comune dell’inanità della vita e anticamera della rassegnazione e della depressione. Camus invece rovescia lo schema, sottolineando la pienezza dell’essere che quell’attività genera in Sisifo, in qualche modo la realizzazione della sua funzione esistenziale. “Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo” è l’affermazione che dovrebbe condurre al superamento di una componente dell’esistenzialismo: l’angoscia, la condizione che attanaglia l’uomo di fronte all’abisso della sua incondizionata libertà. Ci si è più volte posti la domanda se lo scrittore algerino possa essere considerato a tutti gli effetti un esistenzialista. A prescindere dalla difficoltà intrinseca a definire l’esistenzialismo come un movimento e un pensiero compiuti e di conseguenza chi furono effettivamente gli esistenzialisti, credo che la risposta possa essere al tempo stesso sì e no. Perché Camus è Camus, nell’esistenzialismo e a prescindere dall’esistenzialismo. È una domanda che trovo inutile al pari di quella se lo scrittore fu anche filosofo oppure no.
Prima di concludere, due brevi considerazioni su Camus e i giorni nostri. Si è sviluppato alla metà degli anni Dieci di questo secolo in Francia un dibattito sull’opportunità di traslare le spoglie del grande scrittore dal cimitero di Lourmarin al Pantheon per riaffermare non solo l’attualità del suo pensiero ma anche il suo posto d’onore nello spirito pubblico repubblicano della Francia. La proposta avanzata dall’allora Presidente Nicolas Sarkozy scivolò rapidamente dal livello del dibattito a quello della polemica. Una polemica, come spesso avviene in Francia, segnata da una buona dose di radicalità, che ha finito per dividere la sinistra francese e la stessa famiglia nelle persone dei due figli gemelli dello scrittore. Gli argomenti pro e contro sono facilmente intuibili. Porto una semplice impressione personale che può essere viziata dall’emozione che la visita a quel piccolo cimitero mi ha trasmesso. L’equilibrio tra uomo e natura, l’essere parte di quella armonia sensuale che ingloba cielo e terra sembrano in quel luogo pienamente realizzate. Non so se in luogo più austero e istituzionale se ne potrebbe respirare l’effluvio.
Da ultimo se si dà spazio a alcune interpretazioni metaforiche della peste descritta nel romanzo come un riferimento alla allora recente occupazione nazista della Francia e se al tempo stesso si riconosce l’attualità dello scrittore, verrebbe da porsi la domanda su quale sia la peste del tempo presente. Sarebbe facile, o addirittura banale, pensare che fino a poco tempo fa potesse essere individuata nel terrorismo, oggi forse nella pandemia, nel cambiamento climatico, nell’antiscientismo e nel sovranismo razzista, in senso politicamente più pregnante nelle sciagurate teorie liberiste dilaganti nell’ultimo trentennio. Forse coglie più nel segno una frase recente di Papa Francesco a cui andrebbe dato un significato più largo: “Abbiamo proseguito imperterriti pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato”. Forse Camus si riferiva anche al nazismo ma all’interno di un quadro più ampio in cui la peste rappresenta il male, sempre presente come lato oscuro della natura e della coscienza umane e come tale insopprimibile.
A noi piace immaginarlo al momento della sua uscita di scena non nell’intrico mortale delle lamiere dell’auto fuori strada ma, grazie anche alla sua indubbia somiglianza con Humphrey Bogart, come il Rick di Casablanca che si avvia nella nebbia non si sa verso cosa. Saldo, però, nella sua indefettibile convinzione del primato della morale sopra ogni altra causa. E noi, uomini di oggi, sentiamo più che mai il bisogno assoluto del versante pubblico della morale, vale a dire dell’etica come guida saldissima dei comportamenti umani nel momento in cui gli accadimenti ci impongono una vera e propria riprogettazione del nostro vivere civile e sociale. Forse può essere davvero l’occasione di una svolta, o forse siamo ancora condannati all’irrilevanza. Ma una cosa è certa, in entrambi i casi sentiamo Camus terribilmente vicino.
Mauro Agostini è un economista, politico e dirigente d’azienda italiano. E’ stato eletto per tre legislature alla Camera dei Deputati (1994-2006) e per una al Senato (2008-2013). Nel Governo Prodi (2006-2008) è stato sottosegretario al commercio internazionale. Autore di articoli e saggi su temi di economia e politica, è stato direttore generale di Sviluppumbria e membro dei Consigli di Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia e della società di gestione dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco di Assisi”.
