S’immagini un paese o, meglio, una metropoli degli anni 1960/70, con i suoi mezzi di trasporto (aeroporto, autobus, metropolitana, filobus, taxi), alberghi, banche, stazioni di polizia, carceri, tribunali, ospedali, luoghi di culto, cimiteri, parchi, postriboli, mercati e fiere, campi sportivi. Dove la gente lavora, compra i più moderni beni di consumo dell’epoca, festeggia, prega, muore, protesta, anche violentemente. Non vi si trova traccia però né di biblioteche, né di cinema o teatri, solo di cabaret e sale da ballo. Dove, più di ogni altra cosa, colpisce la saturazione dello spazio: un flusso ininterrotto di macchine ma soprattutto di gente che cammina, file ovunque (anche per prendere l’ascensore in albergo), una calca, una ressa pervasiva – perfino nei cimiteri o nei reparti neonatali -, alla quale difficilmente si sfugge, che soffoca in un abbraccio claustrofobico:
Deve essere il reparto maternità: ci sono centinaia di culle in file ordinate, piene di bambini fasciati di bianco. Sono neonati di tutte le razze, come gli adulti di quella città, i tratti somatici più diversi, carnagioni chiare e scure. Anche le sale vicine sono piene di bambini, e quelli che non c’entrano sono sistemati lungo i corridoi o addossati alle pareti. In alcuni lettini ce ne sono due o tre, forse gemelli, o magari mettono insieme i bambini a caso, per mancanza di posti. Poi altri padiglioni, straripanti di piccoli, come se non finissero mai, infermieri in veste bianca che non smettono di portarne altri: dieci, venti per volta, neonati ancora paonazzi o serenamente addormentati… (pp.148/149, ed.Voland).

E soprattutto dove, pur essendoci un aeroporto, un servizio di cambio valuta nell’albergo dove si svolge parte del racconto, souvenir, mappe turistiche, e quant’altro serve al viaggiatore, non si parla nessuna delle lingue più diffuse nel mondo, né delle più rare, non si conoscono le lingue classiche e si usa un alfabeto sconosciuto, con caratteri poco evoluti che ricordano le rune. Si parla invece una lingua dalle sonorità ostiche, fatta di suoni all’apparenza onomatopeici e aleatori, nella quale è quasi impossibile rintracciare strutture regolari, quasi fosse carente di doppia articolazione. Infatti gli abitanti sono spesso descritti come bruti, le parole sono accompagnate da gesti, intonazione, tono della voce in cui prevale l’aggressività, l’antipatia, al meglio l’indifferenza. Nonostante la sua modernità tecnologica, vi è qualcosa di arcaico, tribale, in questa società. Vi scoppierà una sommossa urbana di estrema violenza, in una successione di eventi sanguinolenti di cui non rimane più traccia se non quelle dei buchi delle pallottole sui muri. Una società alienata e alienante, dove l’amore è un’illusione breve destinata a svanire (e qui si può pensare a 1984 o ancora a Noi, di Zamiatin)
Ecco, sommariamente descritto, il posto dove atterra Budai dopo un volo di non sa quante ore, poiché si è addormentato e non ha l’orologio, in un aereo in cui è salito per sbaglio, pensando di recarsi a Helsinki per un convegno di linguistica.
Suscitata da questo errore di orientamento iniziale, si dipana la vicenda narrata in Épépé (1970), dell’ungherese Ferenc Karinthy (1921-1992). Da quella notte in cui viene portato in albergo, non perdiamo mai d’occhio il protagonista a mano a mano che i giorni scorrono, le sue risorse economiche e fisiche scemano, senza un barlume di soluzione della sua situazione disperata, di solitudine, angoscia e smarrimento: non riesce a entrare in comunicazione con nessuno, cercando senza pace in questa metropoli senza confini un modo per andarsene velocemente e ritrovare la sua vita solita, oppure un qualche modo per comunicare con l’esterno. Finiranno i soldi cambiati in moneta locale al suo arrivo, dovrà lavorare, gli capiteranno varie avventure, compresa una effimera relazione amorosa.
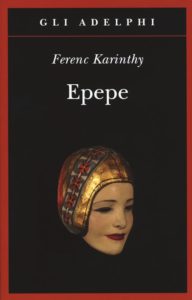 La sua disavventura viene raccontata in una dimensione onirica, caratterizzata da una dilatazione del tempo e dello spazio, che rende la narrazione vertiginosa, quasi nauseante. Le indicazioni cronologiche rimangono precise e apparentemente logiche ma le descrizioni minuziose delle lunghe attese ne distorcono la percezione. Allo stesso modo, lo spazio sembra senza fine, con la descrizione minuziosa degli edifici, delle strade e stradine incessantemente percorse dal protagonista. Così riassunto, il racconto suscita, speriamo, la curiosità. La “scheda di lettura” lascia trasparire un racconto metaforico basato sul topos dell’assurdità del mondo al quale è confrontato l’individuo, dell’incomunicabilità. Risuonano naturalmente echi kafkiani, tanto più per la vicinanza mitteleuropea. Se associamo poi autore ungherese, metropoli tentacolare, insurrezione popolare che si conclude con un bagno di sangue, non può che farsi avanti anche l’interpretazione politica. Si affacciano quindi anche Huxley, Orwell. Non dimentichiamo nemmeno un Robinson Crusoe inversamente smarrito ma altrettanto solitario e I viaggi di Gulliver, sui quali torneremo. E infine aggiungiamo, come fa Emmanuel Carrère nella sua introduzione, W ou le souvenir d’enfance, di Perec.
La sua disavventura viene raccontata in una dimensione onirica, caratterizzata da una dilatazione del tempo e dello spazio, che rende la narrazione vertiginosa, quasi nauseante. Le indicazioni cronologiche rimangono precise e apparentemente logiche ma le descrizioni minuziose delle lunghe attese ne distorcono la percezione. Allo stesso modo, lo spazio sembra senza fine, con la descrizione minuziosa degli edifici, delle strade e stradine incessantemente percorse dal protagonista. Così riassunto, il racconto suscita, speriamo, la curiosità. La “scheda di lettura” lascia trasparire un racconto metaforico basato sul topos dell’assurdità del mondo al quale è confrontato l’individuo, dell’incomunicabilità. Risuonano naturalmente echi kafkiani, tanto più per la vicinanza mitteleuropea. Se associamo poi autore ungherese, metropoli tentacolare, insurrezione popolare che si conclude con un bagno di sangue, non può che farsi avanti anche l’interpretazione politica. Si affacciano quindi anche Huxley, Orwell. Non dimentichiamo nemmeno un Robinson Crusoe inversamente smarrito ma altrettanto solitario e I viaggi di Gulliver, sui quali torneremo. E infine aggiungiamo, come fa Emmanuel Carrère nella sua introduzione, W ou le souvenir d’enfance, di Perec.
Ma, come sottolineano sia Carrère che altri recensori, il testo risulta anche umoristico. Il surrealismo è dietro l’angolo, in alcuni episodi e personaggi totalmente assurdi. L’autore, nato nel 1921 (e morto nel 1992) è figlio del più noto scrittore Frygies Karinthy (1887-1938)[1], famoso per i suoi pastiches letterari e i suoi atteggiamenti pubblici burleschi. Se molte scene sembrano la rappresentazione quasi realistica, appena caricaturale di situazioni quotidiane delle grandi metropoli e /o delle società del mondo sovietico (il mercato, le tavole calde, il metrò sovraffollato), in certi momenti si avverte che l’autore si lascia portare dal gioco, si diverte a immaginare le situazioni più assurde, a spese del suo personaggio. Quindi, se la dimensione esistenziale e quella politica sono indubbiamente al centro delle sue preoccupazioni, non dimentichiamo questo elemento giocoso, non andiamo sempre dietro alle sue intenzioni ideologiche o filosofiche.
Ci proponiamo di lasciare da parte l’analisi dei ricchi procedimenti messi in opera, la qualità, l’originalità, del romanzo, la godibilità (o meno) della lettura[2] per concentrarci su un profondo paradosso, evidente, che nutre sia la struttura narrativa che quella metaforica del racconto: proprio il professore di linguistica stagionato che è Budai, che conosce “una trentina e passa lingue”, in possesso degli strumenti e dei metodi più rigorosi e aggiornati dell’analisi linguistica, non riesce a sbrogliare un solo elemento in grado di fornirgli la chiave d’ingresso di questo linguaggio. Ci si esaurisce per giorni e giorni, cercando disperatamente di cogliere un senso nelle parole che ascolta, nelle innumerevoli tracce scritte che gli capitano sotto mano: dalle monete alle cartine stradali, dagli elenchi telefonici ai volumi che sfoglia in una libreria, le targhette dello zoo, le fatture, i cartelli, pubblicitari e non, tutto ciò che la moderna glottodidattica chiamerebbe “documenti autentici”. Si legge da destra o da sinistra, sono caratteri alfabetici, sillabici, rune[3] o ideogrammi? Si colgono forme ricorrenti che potrebbero dare accesso a una qualche struttura sintattica? Nei suoni pronunciati, è possibile percepire interruzioni in grado di isolare parole? Niente da fare, si scervella da solo, sollecita vari interlocutori, ma non riesce a ottenere risposte soddisfacenti, non approda alla minima regolarità, nemmeno nei suoni. Va sottolineato che l’autore ha avuto egli stesso una formazione linguistica, è stato traduttore (di Molière e Machiavelli fra l’altro). Le pagine e pagine che dedica alle indagini di Budai ne illustrano la competenza, sia metodologica che scientifica. Non trascura nemmeno di riferire i segni comunicativi extralinguistici affidati all’intonazione, alla mimica e al volume della voce e che permettono di percepire gli stati emotivi più palesi dell’interlocutore, in questo caso purtroppo quasi sempre rabbia, fastidio, al meglio indifferenza (raramente benevolenza, simpatia, con l’unica eccezione di Épépé, sulla quale torneremo).
Il fatto quindi che Budai sia un linguista dà luogo a una dimostrazione per assurdo, perciò più efficace, come un caso estremo della ermeticità, della refrattarietà della realtà: anche con tutti i mezzi a disposizione, essa non rivela i suoi segreti.
L’incapacità di Budai, che non è quindi insipienza, ma che lo porta sistematicamente all’impotenza, serve naturalmente l’intento narrativo: acuisce l’impianto iperbolico, vera chiave di volta della narrazione, porta al parossismo l’esasperazione, la frustrazione e la disperazione. E’ quindi tanto più facile per il lettore lasciarsi convincere, dato che l’identificazione con il protagonista è intensa e la successione di fallimenti gli sembra plausibile: il lettore medio non è un linguista, può immaginare se stesso nelle stesse circostanze a decifrare il cinese o l’arabo, o perfino una lingua ad alfabeto latino.
Eppure, persino i geroglifici hanno rivelato i loro segreti, e le difficoltà di decifrazione di un idioma udito e letto quotidianamente non si possono paragonare a quelle dell’etrusco, con il suo corpus limitato, né si può negare che Budai abbia a disposizione, non una, ma molteplici stele di Rosetta.
Egli stesso in certi momenti si rimprovera di essersi specializzato solo in etimologia, evoca i casi noti di lingue decifrate, come l’alfabeto ittita, la cosiddetta “lineare B di Creta”, Grotefend e il persiano, Champollion, ma trova sempre spiegazioni plausibili alla risoluzione degli enigmi – e giustificazioni per se stesso. Per un altro verso però, si reputa responsabile di questa sua incapacità. Per lo meno questo alimenta la sua frustrazione e lo scoramento che lo assale.
Per cui, davanti a cotanto accumulo di fallimenti, a questo punto potrebbe sorgere nel lettore un dubbio: di chi è la colpa, o almeno il limite, della realtà stessa o dell’osservatore?
Paragoniamo ora questa situazione a quella di un protagonista ben più noto: Gulliver. Budai, dicevamo qui sopra, come un Robinson alla rovescia, ma soprattutto un anti Gulliver: quest’ultimo, ogni volta che approda in un nuovo territorio, fa in modo di imparare la lingua e di padroneggiarla rapidamente. In pochi giorni già possiede quel che si chiamerebbe lingua basica, parole utili alla vita quotidiana. Perfino la lingua degli Houyhnhnm, i cavalli – che per le sue componenti fonetiche richiama la lingua sentita da Budai – in poco tempo gli diventa familiare, al punto che dopo pochi mesi è in grado di disquisire addirittura di questioni politiche, sociali o filosofiche con i suoi “padroni”. Come procede Gulliver? Bisogna riconoscere che riceve sempre aiuto da uno degli abitanti, come la gentile bambina di Brobdingnag, il paese dei giganti. Essenzialmente, si basa su elenchi di parole, che ripete e fa ripetere, che trascrive in un quaderno, con la loro traduzione. Tutto abbastanza scontato, ma si può osservare che lo muove soprattutto la curiosità. Certo, la straordinaria rapidità di apprendimento di Gulliver è un artifizio che, come l’osticità della lingua di Épépé, permette di sostenere l’inventiva e colorare il racconto, ma essa veicola anche contenuti. Perché quello che riesce fattibile per Gulliver non lo è per il linguista Budai? Possiamo naturalmente interpretare queste differenze come sintomatiche del clima culturale e delle convinzioni filosofiche dei due tempi diversi in cui vengono scritti i due testi: fiducia nell’opera della ragione, ottimismo pragmatico dell’età dei Lumi, vs perdita di senso, incomunicabilità, appunto, nel mondo contemporaneo. Ma se abbiamo ripetutamente scomodato questo grande tema della modernità, ci appoggeremo ora su un’altra categoria (abusata?) dei nostri tempi: l’impressionante, quasi temibile, intelligenza empatica. Ecco, al di là dell’intrinseca difficoltà della lingua, nella società in cui è approdato Budai scarseggiano sia l’empatia che l’intuizione (i suoi interlocutori, davanti a lui che mostra una piantina della città, imita con le braccia un aereo in volo, sembrano non capire cosa vuole!): di entrambe però anche Budai sembra carente, come pure di autentica curiosità. Uscire dai codici, azzardare ipotesi, è stato quello che ha permesso di decifrare le lingue negli esempi citati. Lui invece avanza cauto, e ogni volta che gli pare di aver trovato una soluzione viene assalito dai dubbi: e se la parola che crede significhi “Hôtel” perché scritta sulla facciata, si riferisse invece al nome stesso dell’albergo? Se invece di indicare “legna e carbone” un cartello volesse dire invece “combustibili”? Una pignoleria castrante. Insomma, Budai cerca di decodificare la lingua in un approccio fondamentalmente intellettuale, laddove Gulliver cerca di impararla, di farla sua, per poter scambiare con i suoi ospiti, che non sono nemmeno suoi simili!
L’unica eccezione in questa solitudine abissale rimane Épépé. Ma chi è Épépé? In questo nome che dà il titolo al racconto si condensano le valenze umoristiche e tragiche della vicenda: Épépé è la dolce, bionda e delicata addetta all’ascensore con la quale Budai riesce a instaurare un rapporto umano, fatto di sguardi e di sorrisi, fino a coronarlo dopo un certo tempo con una notte di amore. Rappresenta per Budai la speranza di ricevere tenerezza e conforto e di vedersi aprire le porte della comprensione della lingua. Tuttavia Épépé, nonostante la sua gentilezza, non riesce a capire che Budai le chiede di aiutarlo, mentre lui la sollecita a pronunciare numeri, o ripetere suoni. Però, nella preziosa intimità notturna, dopo l’amplesso, Épépé si lancia in un lungo monologo in quella lingua così ostica. E lì, finalmente, miracolosamente! Budai “capisce” la sua storia:
“(…) ed ecco che di colpo tutto divenne chiaro. Gli parve di riuscire a seguire quel che diceva, o per lo meno l’essenziale: i dettagli, si sa, non contano… Era uno sfogo su quanto fosse intollerabile la vita a casa sua, la convivenza con tutta quella gente: parenti vari, zii e zie e i due figli del primo matrimonio del marito. E anche coinquilini e subaffittuari, e perfino gente che occupava solo un posto letto per la notte e di cui non riuscivano a liberarsi, vecchi invalidi e malati, nevrotici urlanti e ubriaconi sudici e intrattabili, donne dalla vita equivoca, provviste anch’esse di marmocchi (…).” (p.162, ed. Adelphi).
Poco importa quindi se quello che capisce corrisponde a verità, se è palesemente basato su una successione di topoinarrativi riferiti al cosiddetto socialismo reale. Conta che l’empatia al suo parossismo nell’abbandono amoroso gli ha permesso di varcare i confini individuali per perdersi nella vita dell’altra. Ahimé! Mentre è Robinson che impone un nome a Venerdì, per conto suo Budai, nonostante l’intimità fisica raggiunta, non riesce nemmeno a sapere se lei si chiama Bébébé, Tyétyétyéty, Tété, Gégégé, Pépé,Védédé… E, nella disperazione suscitata dalla incapacità di lei a capire ciò che egli racconta, finirà col picchiarla selvaggiamente. Umorismo e tragedia si condensano quindi in questo nome simile al balbettio di un infante.
La questione della traduzione
Se di lingua e comunicazione si deve parlare, come non affrontare ora la questione della traduzione di un testo scritto in una lingua che poche persone conoscono, a parte gli stessi locutori nativi, dentro e fuori il paese?
Si dà il caso che il romanzo conosca ben due traduzioni in italiano, a distanza relativamente ravvicinata, fatto piuttosto raro anche per autori e testi più noti. Ne dànno forse ragione probabili questioni di diritti e di politica editoriale, non ci è dato saperlo e non c’interessa in questo contesto.
Dell’ungherese si sa che è una lingua della famiglia dell’ugrofinnico. La sua caratteristica maggiore è di essere una lingua agglutinante, ovvero dispiega parole composte con vari suffissi o prefissi (sottoposti a regole sintattiche), indicanti per esempio il caso grammaticale. Spesso quindi va ricercato il nucleo semantico della parola in mezzo a varie appendici. Non esiste indicazione di genere dei sostantivi.
Personalmente, ho sospettato che la successione di suoni registrata da Budai potesse essere una trasposizione umoristica della catena fonetica della lingua ungherese, ma i traduttori francesi, da me interpellati in merito, lo hanno escluso. [4]Insomma, cercare di conoscere così superficialmente la lingua di partenza non dà grandi risultati. Ne consegue che diventa difficile indicare meriti e demeriti delle varie versioni, e comunque fondamentalmente non c’interessa bacchettare né distribuire nastri azzurri, osservare piuttosto, senza esimerci da qualche congettura e impressione di lettura. Lasciamo alla sensibilità di ogni lettore decidere se gli piace il testo che ha sotto gli occhi. Cogliamo invece l’occasione di questa prospettiva leggermente sfalsata per ricavare elementi di analisi comunque utili alla traduttologia e per interessarci, sia pure brevemente, sia alla ricchezza del paratesto che a questioni di ricezione dell’opera.
Una prima traduzione italiana, ad opera di Agi Berta, viene pubblicata da Voland nel 2001. La seconda edizione, a cura di Laura Sgarioto, con una prefazione di Emmanuel Carrère che accompagna anche l’edizione francese, esce nel 2017 presso Adelphi. Prenderemo in mano anche la traduzione francese presso Zulma, 2005 (Denoël, 1999), ad opera di Judith e Pierre Karinthy. Abbiamo la nostra stele di Rosetta!.
I due traduttori francesi, marito e moglie, hanno lo stesso cognome dell’autore: lei è la sua figlia adottiva, lui è un cugino di primo grado (il padre è fratello di Frygies). A loro si devono numerose traduzioni in francese di autori ungheresi, nonché naturalmente di Frygies e Ferenc Karinthy. I dati anagrafici non sono irrilevanti.
La prima traduttrice italiana è di madre lingua ungherese, e non risulta da una ricerca bibliografica che abbia tradotto altri testi letterari.
La seconda traduttrice si era dedicata prima e si dedica tutt’ora alla traduzione di autori ungheresi per la casa editrice Adelphi e anche per altre.
Non sempre è possibile sapere come lavorano i traduttori. Ne abbiamo però una testimonianza diretta per i traduttori francesi : in una intervista di Guillaume Richez, nel blog Les Imposteurs, del 16 febbraio 2017 , si viene a sapere che Judith è traduttrice professionale da sempre. Pierre è stato ingegnere e si dedica alla traduzione insieme alla moglie da circa 25 anni. Preziose le loro delucidazioni circa il loro metodo di lavoro “a quattro mani”: “Judith ha il testo in mano. Pierre sta seduto alla tastiera. Judith propone una traduzione, frase dopo frase. Da lì iniziamo una discussione. Prendiamo una prima decisione. Seguiranno dalle tre alle cinque riletture.”
Quanto segue va quindi preso come un esercizio limitato, il cui scopo è di evidenziare alcuni dei procedimenti messi in opera nella pratica traduttiva.
Procederemo con un primo campione, scelto per la ricchezza lessicale e per le brevi descrizioni ambientali, assai significative in tutto il racconto. Vengono presentate in successione le frasi che si corrispondono, nell’ordine: traduzione francese, traduzione Voland in corsivo, traduzione Adelphi in grassetto:
Arrivé en haut, il est sur une place spacieuse; le ciel est toujours opaque, couleur d’étain, il bruine: un crachin silencieux et froid.
Sbuca su una larga piazza: ritrova il cielo plumbeo impenetrabile e una lieve, silenziosa e fredda pioggerella.
Sbucò in una grande piazza; il cielo era plumbeo, coperto da una coltre impenetrabile di nubi, e cadeva una pioviggine silenziosa e gelida
En partant au hasard, il constate aussitôt que le fourmillement des piétons n’est nullement inférieur de ce côté-ci de la ville.
Mentre si incammina non può fare a meno di notare che anche lì lo sciamare della gente è impressionante.
La folla era densa come ovunque, pensò non appena vi si immerse, senza darsi una meta precisa.
Il doit se trouver sur une foire ou un marché, on y vend de tout dans des stands, sur des étalages ou simplement répandu à même les pavés; des camelots font l’article, un déluge de musique descend de haut-parleurs hurlants.
Deve trovarsi in qualche mercato o fiera: si vendono articoli di ogni genere in chioschi e bancarelle, ma anche per terra. Si tratta per lo più di roba usata. Strilli di banditori, musica, altoparlanti che risuonano
Doveva essere finito in un mercato o in una fiera: sulle bancarelle e perfino sul selciato si vendeva di tutto, i commercianti urlavano a squarciagola, musica e altoparlanti al massimo volume.
En progressant péniblement à travers cette densité, emporté par le flot lent qui recouvre tout l’espace, il lui semble qu’on offre essentiellement des objets usagés:
Intanto la folla inarrestabile lo trascina intorno alla piazza (vedi sopra: Si tratta per lo più di roba usata ) :
C’era soprattutto roba di seconda mano, gli parve, mentre avanzava adagio intorno alla piazza, trasportato dal flusso:
meubles, lustres, habits, fourrures fatiguées, vaisselle, tapis, bric-à-brac, antiquités, marchandises rebutées, jouets d’enfants, ballons, énormes blocs de mousse synthétique, tuyaux enroulés de différentes couleurs et de différentes grosseurs, pneus, baudruches, verres à vitre.
mobili, lampadari, vestiti, pelli logore, stoviglie, tappeti, cianfrusaglie, prodotti industriali di scarto, pezzi difettosi, giocattoli, palloni, cose di plastica colorata, tubi di vario colore e misura, pneumatici, taniche, bicchieri di vetro
mobili, lampadari, abiti, pellicce consunte, vasellame, tappeti, cianfrusaglie, oggetti d’antiquariato, prodotti difettosi o di scarto, giocattoli, palloni, grossi tagli di gommapiuma, tubi di ogni colore e diametro arrotolati e impilati, pneumatici, canne da giardino, lastre di vetro.
Sul piano strettamente lessicale, notiamo alcune discrepanze, più o meno marcate:
– énormes blocs de mousse synthétique = cose di plastica colorata = grossi tagli di gommapiuma.
gomma piuma vs plastica, enormi o grossi vs nessun indicazione del volume, colorata vs zero indicazione
– baudruches, verres à vitre = taniche, bicchieri di vetro = canne da giardino, lastre di vetro.
Qui, le differenze sono notevoli.
baudruche: la parola francese indica “une pellicule de caoutchouc dont on fait des ballons ou autres objets gonflables” (Trésor de la Langue Française). In altre parole, il materiale (a base di caucciù) dei palloncini gonfiabili di una volta. Oltre a essere molto specifica, la parola ha il significato figurato, tuttora vivace, di “pallone gonfiato”. Nelle traduzioni italiane abbiamo invece “taniche” e “canne da giardino”. Ovvero un contenitore più o meno voluminoso e un oggetto che potrebbe essere piuttosto a forma di tubo. Conoscendo la tendenza dei traduttori francesi a preferire vocaboli più espressivi e fantasiosi, si potrebbe vedere nella loro scelta uno slittamento da “tanica di plastica” a “oggetto di plastica a forma di pallone”. Le “canne da giardino” restano un mistero.
– sempre a proposito della ricerca di forme più espressive e a volte (in altre parti del testo) immaginifiche, si possono notare le descrizioni del cielo, tutte esatte, ma tutte diverse: le ciel est toujours opaque, couleur d’étain = il cielo plumbeo impenetrabile = il cielo era plumbeo, coperto da una coltre impenetrabile di nubi.
– E ancora: des camelots font l’article = strilli di banditori = i commercianti urlavano a squarciagola. I “camelots” sono effettivamente “banditori”; “commercianti” invece è un iperonimo, si tratta di una traduzione letterale o di un’interpretazione? Infine, dalle due traduzioni italiane, si può supporre che il testo originale usi un verbo sinonimo di “urlare”, “strillare”, che però non troviamo nella traduzione francese. In essa tuttavia la descrizione si arricchisce attraverso una locuzione verbale (“faire l’article”) usata solitamente per descrivere ciò che fanno i venditori ambulanti, ovvero aggiungendo alla voce strillante la rappresentazione dei gesti, l’animazione della scena.
Ci accontenteremo di questa tipologia molto succinta delle differenti traduzioni, per dare un’idea delle tante varianti che possono derivare dall’interpretazione e dalle scelte che ne conseguono, fra le possibilità offerte dalla lingua, talvolta amplissime e talvolta molto ristrette.
Veniamo ora alla differenza più palese fra le versioni, che si evidenzia sul piano sintattico, nella scelta dei tempi verbali: nel testo francese la narrazione avviene al presente: “Il passe un bon quart d’heure avant de pouvoir accéder à un ascenseur” diventa nella versione Voland “Passa un buon quarto d’ora prima di poter entrare nell’ascensore”. Ma la versione Adelphi ricorre al passato remoto, con conseguente adeguamento dei tempi e dei modi in funzione della concordanza: “Ci volle un quarto d’ora perché arrivasse il suo turno. ”
In questo secondo esempio, tratto da un brano in cui sono descritte in rapida successione varie azioni, si palesa la differenza di tono che ne consegue:
“Il prend une douche, il se rase devant la glace, il met du linge propre et, comme à son habitude, lave immédiatement son linge sale et l’étale sur la pomme de douche et les robinets.” (p.21)
“Dopo la doccia si rade davanti allo specchio, si cambia la biancheria e come d’abitudine lava subito quella usata e la appende ai rubinetti e sul bulbo della doccia.” (Voland p.12).
“Si fece una doccia, si rase davanti allo specchio, indossò della biancheria pulita; quella usata la lavò subito, com’era sua abitudine, e la appese ad asciugare sui rubinetti e sul braccio della doccia.” (p.25).
E’ in questa scelta più radicale che si riscontra la maggiore differenza fra le due versioni italiane, e non è da poco.
I traduttori francesi, da me interrogati in merito alla versione originale, mi hanno confermato che la questione dei tempi verbali gli si era presentata fin dall’inizio, e che la situazione disperata di Budai non prevedeva futuro, quindi nemmeno una narrazione al passato. Dettaglio non da poco: l’autore, ancora vivo al momento del progetto, aveva approvato questa scelta.
Si tratta quindi di una loro decisione deliberata fin dall’inizio, basata su una specifica interpretazione del racconto, ma avallata dallo stesso autore con il quale, in quanto parenti, avevano la possibilità di interloquire.
Indiscutibilmente, i quattro traduttori sono ottimi conoscitori delle due lingue, attenti alla “fedeltà”, con tutte le ambiguità insite in questo termine. Le qualità del linguaggio, delle scelte lessicali, il modo di superare gli ostacoli sono notevoli. Eppure abbiamo tre testi la cui colorazione finale risulta diversamente sfumata.
Si può azzardare una conclusione: la prima traduzione italiana si è con ogni probabilità avvalsa della traduzione francese già esistente, date le somiglianze sia nel lessico che nella sintassi e l’andamento della narrazione. La seconda traduzione italiana appare più filologica, nelle scelte lessicali e nell’aderenza al testo, adottandone gli stessi tempi verbali e senza le piccole omissioni della prima traduzione.
Si notano maggiori sviluppi perifrastici nella traduzione francese, maggiore libertà nelle scelte espressive. Questo non stupisce considerando sia la formazione sia il modo di procedere dei due traduttori francesi, in qualche modo legittimati dalla loro parentela diretta con l’autore. Nella prima traduzione italiana si nota una ricerca di precisione e anche di colore, senza osare l’invenzione come in francese: giusta cautela. Apparentemente più filologico il terzo, si diceva, con la scelta dei tempi verbali che però finisce talvolta col nuocere alla immediatezza e alla dinamicità del testo. Nell’insieme, quest’ultimo risulta più forbito, più consono a stilemi classici, (nella linea editoriale Adelphi?) : vasellame anziché stoviglie, pioviggine anziché pioggerella, ecc, per dare piccoli esempi.
E non ci è stato dato di leggere la versione inglese, in cui il titolo scelto, Metropole, in riferimento al Metropolis di Fritz Lang, fornisce di per sé una ineludibile chiave di lettura…
Non va quindi dimenticato che nell’analisi di una traduzione, entrano in considerazione il periodo in cui viene composta, gli stilemi in auge – specie nella narrativa e nelle sue mode (che dire dei titoli composti da interi sintagmi, per esempio?)-, le esigenze editoriali, le attese dei lettori[5] e vice versa l’audacia, il coraggio/ provocazione di autori/autrici e… traduttori/trici.[6]
Quale opera stiamo leggendo, noi che non conosciamo l’ungherese? Senza scomodare né Walter Benjamin né la Torà, ci possiamo chiedere quale palimpsesto si nasconde dietro le differenti versioni che abbiamo in mano. Più modestamente, sottolineeremo che l’impossibilità di accedere al testo originale, il quale esiste da qualche parte ovviamente a beneficio di chi intende l’ungherese, evidenzia per contrasto la ricchezza dei contenuti aperti da infinite modalità di lettura,[7] fra le quali la traduzione occupa una sua specifica posizione. Un testo nato dalle tre versioni e che non sarà mai trascritto –et pour cause-, ma esiste nella mente di ogni lettore ed è la sua personale interpretazione.
D’altronde, en abyme, dove esiste la lingua che Budai non è capace di interpretare, ma comunque “sente”? Ovvero, chi è stato capace di trascrivere i campioni di discorso che il narratore riferisce nel testo?
“Alla fine il poliziotto annuisce e punta il dito verso di lui:
– Csetentcse gluglubb? Guluglulubb?” (Voland, p.36)
” (…) lo prende per un braccio e lo spinge verso il piano di scarico dell’automezzo con queste parole:
-Dumucce brudimruscure! Klutt!…” (Voland, p.49)
Non Budai, nonostante i suoi innumerevoli tentativi di registrarli su carta, certamente l’autore che tutto ha inventato.
Le nostre disquisizioni intorno a un testo inaccessibile ai più nella sua lingua originale, tradotto in modo diverso anche in una stessa lingua, hanno riacceso per noi il tema dell’incomunicabilità in una sua ennesima variante nella cultura occidentale. Ci piace pensare che, finché ci saranno degli individui interessati a inventare e altri a interrogare, a fare da tramite fra chi cerca di capire e chi meno, un certo grado di comunicazione, anche zoppa, anche monca, rimane possibile. Merita per lo meno di essere tentata.
Odile Martinez Dell’Orso
[1] Autore famoso anche per la teoria dei “sei gradi di separazione”, esposta in un suo racconto, Catene ( 1929) e rimessa in auge in tempi più recenti con l’adattamento nel film omonimo di Schepisi (1993, da una pièce teatrale di John Guare).
[2] Andare a curiosare sul Web è diventato vizio comune, diciamolo per onestà. Si può così sapere di lettori che hanno abbandonato la lettura per soverchia ansia dovuta alle lunghe peregrinazioni del protagonista senza mai un esito positivo e fastidio per l’accumulo di descrizioni e di situazioni strambe.
[3] Va sottolineato che lo stesso ungherese possiede una scrittura runica, usata fino alla metà dell’Ottocento, ritornata in auge recentemente, e pare, con addentellati di ordine politico che non è qui il luogo di valutare.
[4] Sono entrata in contatto via mail con i traduttori francesi nel marzo 2019, ed ho ricevuto a brevissimo giro di posta una risposta molto cortese e aperta firmata da Pierre Karinthy.
[5] A quale stile è abituato il lettore, quale registro di lingua predilige? Ad alcuni l’uso del passato remoto apparirà come una messa a distanza, ad altri invece darà la rassicurante familiarità dei testi della tradizione classica.
[6] Si rimanda alle sofisticatissime analisi di Nabokov riguardanti la possibilità per i lettori russi dell’Ottocento di accedere ai testi di letteratura inglese essenzialmente attraverso traduzione francesi. Egli sottolinea quanto abbiano potuto influenzare Puškin nella redazione del suo Eugenio Onegin. Di rimando, quanto sia necessario per il traduttore di Puškin averne consapevolezza: “Il traduttore inglese di Puškin deve essere molto attento a distinguere fra il debito del suo autore verso Byron e quello con Pichot [ovvero il – pessimo, secondo l’impietoso Nabokov – traduttore di Byron in francese].”, in Vladimir Nabokov, Traduzioni pericolose (scritti 1941-1969), a cura di Chiara Montini, Mucchi Editore, 2019, p.77.
[7] Cfr. Umberto Eco, Opera aperta, Bompiani, 1962; Lector in fabula, Bompiani,1979
